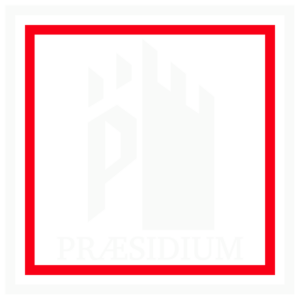Alla fine, un accordo è stato trovato. Il famoso Recovery Fund sembra essere passato.
Rispetto alla proposta iniziale di una dotazione di 750 miliardi – di cui 500 in sovvenzioni e 250 miliardi in prestiti – le negoziazioni dei frugali hanno ribilanciato la dotazione di sovvenzioni, 390 miliardi, a favore dei prestiti, cresciuti a 360 miliardi.
Restano, in ogni caso, le obiezioni già mosse a questo strumento. Circa le sovvenzioni, bisogna specificare che è in un certo senso improprio parlare di “fondo perduto“, in quanto i fondi concessi deriveranno dal budget 2021-2027 o Multiannual Financial Framework (MFF), il quale al momento è finanziato tramite contribuzioni da parte degli Stati Membri.
Significa che, crescendo il bilancio, cresceranno i contribuiti e quindi anche gli esborsi alla UE, versati anche dall’Italia. Al momento sembra che le concessioni di fondi avverranno in maniera asimmetrica rispetto al peso del PIL di ogni economia; se dovessero essere confermati i calcoli di Palazzo Chigi – che parla di 81 miliardi di sovvenzioni per l’Italia – significherebbe avere accesso a circa il 20% dei contributi del fondo contro un peso del nostro PIL (sul quale dovrebbero essere calcolati gli incrementi di contributi al MFF) di circa il 14%.
Perciò, l’aiuto vero e proprio sarebbe stimabile tra i circa 20 e i 30 miliardi. Ovviamente poco rispetto alla gigantesca caduta del PIL, che si profila nel 2020 nell’ordine del 10 o 11%, circa 180 miliardi.
Troppo poco e forse troppo tardi, nel caso gli aiuti dovessero arrivare solo nel 2021 o ancora più in là, creando anche un disallineamento temporale tra lo shock negativo e l’intervento correttivo.
Vi sono poi i correttivi, con effetti ancora da stimare, che i nordici hanno richiesto al budget ordinario della UE per i programmi correnti a sostegno di agricoltura, investimenti, innovazione, etc…
Da non commentare invece la quota di prestiti, di cui si parla per l’Italia di circa 120 o 130 miliardi, dal momento che si tratta né più né meno di nuovo debito per l’Italia. Debito differente dal debito pubblico ordinario solo perché per accedervi l’Italia non emetterà in proprio titoli, ma dovrà passare per l’intermediazione della UE.
Dalle ultime aste di BTP e BTP Italia, riservate a risparmiatori italiani, la domanda di titoli ha superato largamente l’offerta, con proposte di acquisto complessive superiori ai 100 miliardi per asta.
In luogo di accedere ai 120 miliardi di prestiti del Recovery Fund avremmo potuto benissimo o organizzare un’asta speciale di titoli rivolti a risparmiatori italiani o emettere un’asta ordinaria sul mercato con acquisto di Banca d’Italia, nel quadro di un’operazione di politica monetaria.
In entrambi i casi, il debito emesso avrebbe avuto un tasso, e quindi un costo per lo Stato, leggermente superiore al costo che avrà il debito emesso dal Recovery Fund. Tuttavia, tali rendimenti sarebbero stati distribuiti o a favore di soggetti residenti in Italia (restando in circolo nell’aggregato dell’economia italiana), oppure rigirati da Banca d’Italia allo Stato.
Ciò che d’altra parte sembra che molti non colgano (o non vogliano cogliere), è che i soldi che distribuirà il Recovery Fund non escono fuori da una sorta di forziere pieno di zecchini d’oro presente a Bruxelles, da spartirsi col coltello fra i denti e a forza di pugni sul tavolo. Fosse stato così avrebbe avuto senso “tifare Conte per tifare Italia”, sperando di accaparrarsi quanto più possibile per tornarsene con il lauto bottino.
Peccato che la situazione sia leggermente diversa e un po’ più complessa.
Tutti i 750 miliardi al momento non ci sono e il fondo li dovrà reperire sul mercato emettendo titoli di debito targati Recovery Fund, di fatto emettendo degli Eurobond.
L’implicazione di questo passo è enorme. L’emissione di un debito comune implica necessariamente una forma di gestione comune delle risorse e infatti l’accordo prevede che sia la Commissione, in congiunzione con l’Ecofin, a gestire il Recovery Fund e l’allocazione di risorse in favore degli Stati membri.
In tal modo, la Commissione si trasforma, da “garante dei trattati” e da “agente degli Stati Membri”, in un vero e proprio esecutivo dell’UE rivestito di competenze fiscali.
Gli Stati Membri per accedere ai fondi del Recovery Fund dovranno dare le chiavi di casa propria alla Commissione. Per intenderci, la legge di bilancio che si discute ogni anno in Parlamento sarà sostanzialmente sottomessa non tanto all’approvazione del Parlamento, passaggio pro forma, quanto a quello della Commissione.
Similmente a quanto previsto nel MES, il cui board era autorizzato a chiedere “riforme strutturali” al paese debitore prima della concessione dei fondi, la Commissione e l’Ecofin approveranno i piani di spesa nazionali e impartiranno raccomandazioni specifiche allo Stato Membro che dovrà seguire specifici “target” e rispettare determinate “milestones” per giustificare la continuazione nell’utilizzo ai fondi.
Il Consiglio Europeo avrà invece un ruolo di sorveglianza, potendo richiedere, a maggioranza qualificata, la revoca dei fondi concessi nel caso alcuni paesi nutrano dubbi sulla solvibilità del debitore.
L’Olanda chiedeva un controllo deferito totalmente al Consiglio Europeo, con decisioni da prendersi all’unanimità, per avere un efficace potere di veto. Il fatto che abbia sostanzialmente fallito, su quest’ultima richiesta, non è tanto una vittoria per noi, quanto una consacrazione degli organi comunitari ad assumere un ruolo federativo al di sopra di tutti gli Stati Membri.
Verosimilmente le “riforme” che ci verranno richieste saranno connotate da altre manovre lacrime e sangue (stile governo Monti), in cui l’aumento degli investimenti e della produttività del tessuto economico, con ogni probabilità, non saranno in grado di compensarne il naturale effetto recessivo.
Quello che resta però sicuramente segnato è che si apre una fase nuova, in cui il progetto di integrazione federale dell’Unione Europea si può dire pressocché completato.
La portata del Recovery Fund difficilmente potrà evitare all’Italia il suo processo di stagnazione e deindustrializzazione. Con la Commissione e il Consiglio ricoperti di competenza fiscale, nasce il contraltare al sistema dell’Euro e alla BCE, che non si trova più ad essere l’unica vera istituzione federale della UE.
La macroscopica asimmetria del sistema economico europeo, data dalla presenza di un’unione monetaria in assenza di unione fiscale, va a scomparire. I prossimi QE o operazioni di mercato della BCE non andranno più ad acquistare percentuali di debito pubblico dei singoli Stati Membri, ma direttamente il debito emesso a livello centrale che, maggiormente stabile, andrà presto a sostituire le emissioni ordinarie. Si riducono così drasticamente le probabilità di una rottura dell’unione monetaria.
Il processo di soffocamento delle nazioni europee si avvia ormai a compimento. Gli Stati, tutti gli Stati, del nord come del sud, sono deferiti oggi al ruolo di province del superstato europeo.
Province litigiose, certo, province destinate a prendere tragitti di crescita divergenti, tuttavia tutte province e non più Stati in senso proprio.