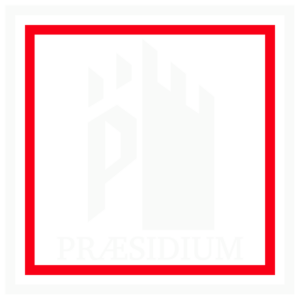I valori dell’unità, dell’indivisibilità della Repubblica, del riconoscimento delle autonomie e della loro relativa condizione, tutti concetti presenti nell’art. 5 della Costituzione repubblicana vigente, hanno un significato ampio ed elastico, potendo manifestarsi, come del resto è storicamente avvenuto, in una pluralità di varianti, ma mantenendo al contempo un contenuto univoco ed essenziale.
Pertanto, esclusa ogni forma di indipendenza da parte delle Regioni ordinarie e speciali, le quali non godono del requisito della sovranità (sent. n. 365/2007 Corte cost.) ed operano all’interno di un ordinamento costituzionale ove unità e indivisibilità sono intese in senso assoluto (sent. n. 118/2015 Corte cost.), essendo rimasta minoritaria la tesi di un loro bilanciamento con il principio di autodeterminazione dei popoli (del quale va comunque dimostrato non tanto il suo accoglimento nell’ordinamento interno, pacifico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Testo fondamentale, trattandosi di consuetudine internazionale, ma il suo carattere di principio costituzionale supremo – sul punto si vedano le riflessioni del prof. Franco Modugno), le stesse godono, per Costituzione, di autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria che, per Valle d’Aosta/Valleé d’Aoste, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e Trentino Alto Adige/Südtirol, è prevista nei rispettivi Statuti adottati con la forma della legge costituzionale (art. 116, comma 1, Cost.).
Il legislatore costituente, dunque, per ragioni storiche oggi ampiamente superate, ha posto esso stesso le basi per una prima differenziazione tra le Regioni italiane già nel 1948, sebbene l’avvio del regionalismo ordinario risalga agli anni ’70 del secolo scorso. Al fine di far finta di rimediare a questa diversificazione evidente, con l’entrata in vigore della pessima legge di revisione costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (riforma del c.d. Titolo V), grazie alla disposizione del comma 3 dell’art. 116, si è attribuita alle Regioni ordinarie la facoltà (non l’obbligo) di chiedere “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, ponendo le premesse per quello che la dottrina costituzionalista ha chiamato semi-specialità o regionalismo differenziato (rispetto a che cosa, però, se tutte decidono di chiederlo?).
Ora, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nel 2017 (dopo alcuni tentativi andati a vuoto degli anni precedenti), sia pure con modalità e richieste diverse hanno messo in moto l’iter per ottenere una maggiore autonomia. Le ultime due hanno celebrato un referendum consultivo regionale per una legittimazione popolare dell’iniziativa dei Consigli regionali, su cui non mancano, comunque, le criticità, soprattutto in merito all’inutile e costoso referendum veneto, introdotto da una legge regionale ad hoc, la n. 15/2014, nonostante la “benevola”, ma discutibile, sentenza n. 118/2015 della Corte costituzionale.
Emiliani, romagnoli, lombardi e veneti sono convinti, perché così lascia intendere la loro classe politica, che avranno più competenze e più risorse, maggiore efficienza e decentramento della responsabilità, con conseguente controllo sull’operato del decisore regionale. Vediamo di smentire questi luoghi comuni. In primo luogo, l’efficienza di un servizio non dipende dal livello cui esso è allocato, ma dalle capacità, dalle competenze e dalla serietà degli apparati politici e amministrativi ad esso preposti. Se si fosse avviata una seria sburocratizzazione della elefantiaca macchina statale e i partiti avessero svolto una vera funzione di selezione meritocratica della classe politica, noi potremmo avere uno Stato efficiente dalle Alpi a Lampedusa, evitando tutta questa pletora di persone giuridiche pubbliche a base territoriale (le Regioni in primis), molte delle quali sono estranee alla tradizione giuridica italiana.
In secondo luogo, qualora dovesse concludersi il procedimento dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, le Regioni avranno frammenti di competenze la maggior parte delle quali di natura amministrativa. Infatti, il vizio di fondo del regionalismo italiano è costituito dalle “famose materie” – “pagine bianche”, le definiva il grande costituzionalista Livio Paladin – i cui contenuti sono stati riempiti dagli interventi della Corte costituzionale.
Inoltre, il giudice delle leggi non solo ha individuato, all’interno delle materie ove si annidano una molteplicità di politiche pubbliche, aspetti non frammentabili e stabilito come alcune – pensiamo alla tutela dell’ambiente – sono non materie, o meglio valori (sent. n. 407/2002 Corte cost.) che già oggi le Regioni ordinarie possono realizzare negli ambiti di loro spettanza (ad esempio, essendo le realtà regionali titolari della potestà concorrente sul governo del territorio, cioé l’urbanistica e l’edilizia, fin da ora hanno la possibilità di rendere operante il valore della tutela ambientale in questo importante settore), ma anche, dopo la riforma del 2001, ha utilizzato tutta una serie di criteri (prevalenza, chiamata in sussidiarietà, etc..) per giustificare l’attribuzione alla potestà legislativa statale di numerosi ambiti materiali, sottraendoli alle amministrazioni regionali.
Ne consegue, dunque, che il conferimento dallo Stato alle Regioni delle materie ai sensi del comma 3 dell’art. 116 della Costituzione (il Veneto le ha chieste tutte e 23) deve necessariamente scontare l’ipoteca della Corte costituzionale.
In terzo luogo, la maggiore autonomia rimane conferita in un “regime di concessione”. È vero che una fonte statale primaria di produzione del diritto non potrebbe né abrogare, né modificare, né derogare la legge, approvata dal Parlamento italiano a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di attribuzione delle maggiori forme e condizioni particolari di autonomia, ma che cosa accadrebbe se una maggioranza parlamentare, in futuro, decidesse di modificare, con legge costituzionale ex art. 138, l’art. 116, comma 3, Cost.? La “madre di tutte le battaglie”, che deve restare ovviamente tale per farne uno strumento di propaganda politica, diverrebbe una vittoria di Pirro.
La immaginate la Lega di Matteo Salvini – alleata con Fratelli d’Italia che ha una posizione giustamente molto scettica sul tema – andare al governo del Paese e conferire, rectius cedere, alle Regioni settori strategici sui quali poi non avere più voce in capitolo?
In quarto luogo, la questione delle risorse. Premesso che il procedimento di cui all’art. 116, comma 3, Cost. richiama i principi dell’art. 119 per evitare i rischi di un “regionalismo solipsistico”, le bozze di intesa del febbraio 2019 prevedono un passaggio dalla spesa storica ai fabbisogni standard. Ora, a riguardo, non solo manca completamente il richiamo alla legge ordinaria dello Stato n. 42/2009 (chiamata impropriamente legge sul “federalismo fiscale”) e al d.lgs. n. 68/2011, il cui rinvio al 2020 non giustifica il prescinderne, ma lo stesso concetto di fabbisogno standard è a sua volta “negoziato”. In altri termini, l’opposto di una vera autonomia finanziaria.
Durante il risorgimento l’Italia ha perduto il treno della “via federalista” (Cattaneo); oggi, invece, si ritrova con 20 carrozzoni che non solo creano cortocircuiti decisionali (si veda durante la fase 1 e 2 dell’emergenza Covid-19), ma sono divenuti negli anni strumenti per mantenere un ramificato sistema di potere lobbistico. Torniamo, allora, alle città-Stato, puntando e rivitalizzando la nostra tradizione comunale e finiamola di raccontare bugie ai veneti, ai lombardi, agli emiliani, ai romagnoli e a tutti i cittadini delle Regioni ad ordinamento comune che intendono intraprendere questa strada della “finta” autonomia.