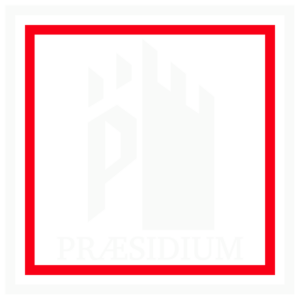Strage di Bologna: un affare di Stato – 1^ parte
Strage di Bologna: un affare di Stato – 2^ parte
Strage di Bologna: un affare di Stato – 3^ parte
Strage di Bologna: un affare di Stato – 4^ parte
Il “peso ambientale” descritto dall’avvocato Montorzi aveva cominciato a farsi sentire a macerie ancora fumanti. In un comunicato apparso il 5 agosto 1980 su L’Unità, il comitato esecutivo di Magistratura Democratica dell’Emilia Romagna affermava che l’attentato portava “l’inequivocabile segno nazifascista”.
Nessuna indagine puntò infatti mai su ambienti diversi da quelli “nazifascisti”.
Fino a che, nel 2005, fu per la prima volta data pubblica rilevanza alla presenza in un albergo a Bologna, la notte fra l’1 e il 2 agosto 1980 di un tedesco, Thomas Kram, esperto di esplosivi e inserito nel gruppo facente capo a Ilich Ramirez Sanchez, meglio noto come Carlos, un terrorista marxista, autore di sanguinosi attentati in tutto il mondo e legato in particolare ad un gruppo palestinese di estrema sinistra, il FPLP , formazione di cui parlammo già nella prima parte di questo scritto. Uno dei suoi esponenti di rilievo, Abu Yjad, poche settimane dopo la strage aveva indicato in estremisti di destra italiani addestrati nei campi cristiano-maroniti in Libano, gli autori del fatto e la giornalista di estrema sinistra e filo-palestinese Rita Porena aveva provveduto a diffondere il comunicato.
Notizie specifiche sul conto di Kram non erano presenti nel fascicolo delle indagini del 2 agosto, ma il suo nome fu in quei giorni oggetto di una fitta corrispondenza fra la Questura di Bologna e la Ucigos di Roma, dove era segnalata la necessità di un controllo, data la sua appartenenza a gruppi estremisti tedeschi. Nessuna ulteriore indagine ne era però scaturita.
Neppure quando – e qui il “peso ambientale” si fece sentire eccome – nel 2001 il capo della polizia, Di Gennaro, segnalò compiutamente alla Procura di Bologna tutte le circostanze relative alla persona del Kram e alla sua presenza a Bologna; di lui avevano infatti richiesto informazioni le autorità tedesche che si stavano in quel momento occupando di lui e che avevano a loro volta fornito elementi alla polizia italiana.
Il fascicolo finì sul tavolo di un pubblico ministero bolognese di Magistratura Democratica, il quale, invece di aprire un procedimento penale c.d. “modello 21”, ossia a carico di un indagato identificato, come lo era Kram, ne aprì uno contro ignoti; ciò che gli consentì, poco dopo, di provvedere direttamente all’archiviazione senza passare per il vaglio di un giudice. A capo della Procura, in quel preciso periodo vi era un altro magistrato, anch’esso appartenente a quella corrente.
L’attentato doveva o non doveva essere di “inequivocabile segno nazifascista”?
Il magheggio fu scoperto qualche anno dopo e determinò addirittura la convocazione dei due magistrati davanti alla commissione Mitrokhin che aveva cominciato ad occuparsi di Carlos e del terrorismo legato al mondo d’oltre cortina.
Un procedimento penale fu poi regolarmente aperto e, dopo anni di indagine, archiviato.
La sola presenza del Kram a Bologna non poteva sicuramente costituire un elemento sufficiente a fondare un processo. Peraltro, il nuovo PM non mancò di sottolineare l’esistenza di un “grumo di sospetti” che l’inchiesta, e in particolare l’interrogatorio del tedesco, non era riuscita a sciogliere.
Ma torniamo al Libano e da lì facciamo un altro passo indietro, spostandoci a Ortona dove, nel novembre del 1979, alcuni esponenti dell’Autonomia furono sorpresi con due missili terra-aria; fu un attimo per gli investigatori risalire, attraverso di loro, ad Abu Saleh, un giordano residente a Bologna e fiduciario in Italia del FPLP, il gruppo che si era procurato i due ordigni.
Durante il processo per direttissima davanti al Tribunale di Chieti, giunse al presidente del collegio una strana richiesta proveniente da George Habash, capo della medesima organizzazione, il quale in una lettera informava la giustizia che quel trasporto era avvenuto d’accordo coi Servizi italiani.
Il fatto ebbe qualche risonanza giornalistica, ne scaturì anche un’interrogazione parlamentare, ma non ebbe ulteriore seguito. Il tribunale ovviamente non tenne in conto quella lettera, condannò Abu Saleh e gli altri, mantenendoli in stato di carcerazione.
Cosa chiedeva in concreto quella lettera? Il rispetto degli accordi del c.d. “Lodo Moro”, quel protocollo segreto sottoscritto dal governo italiano con le organizzazioni palestinesi, volto a impedire attentati sul nostro territorio in cambio della libertà di farvi transitare impunemente armi ed esplosivo.
Quel che non si seppe allora, e fu tenuto sempre nascosto fino all’altro ieri, oltre all’esistenza di quel miserabile accordo – che mortificava la nostra sovranità e che rappresentava un tradimento nei confronti di nazioni vicine e alleate che, a differenza nostra, potevano essere colpite grazie agli spostamenti da noi ufficiosamente autorizzati di terroristi medio-orientali – è che già alla fine del 1979 erano pervenuti alla stazione SISMI di Beirut e poi da lì trasmessi dal colonnello Giovannone a Roma, continui messaggi minacciosi del FPLP che chiedeva la liberazione di Saleh.
Molti di questi dispacci sono ancora coperti dal segreto di Stato ed è davvero singolare che a chiederne la pubblicazione siano i difensori di Gilberto Cavallini e non l’Associazione dei Familiari delle Vittime.
Alcuni però sono state diffusi e vale davvero la pena trascriverne il contenuto, che non ha bisogno di alcuna chiosa.
In un dispaccio del 18 dicembre 1979 si riferiva che “L’interlocutore Taisir Qubaa ha minacciato immediata azione e dura rappresaglia nel momento in cui venisse a conoscenza del rifiuto o del non rispetto dell’impegno richiesto”
In un dispaccio del 14 aprile 1980 si riferiva che “Fplp (Abbas) notifica che gli elementi moderati dell’organizzazione sono riusciti sino ad ora a bloccare ogni operazione a carattere intimidatorio nei confronti dell’Italia, voluta dai membri del politbourot, si trovano attualmente pressati ed in seria difficoltà di fronte all’atteggiamento minaccioso degli elementi estremisti dell’Fplp. Inutile rivolgersi all’Olp perché ‘non sarebbe in grado di prevenire l’effettuazione di una operazione terroristica che sarebbe probabilmente affidata ad elementi estranei all’Fplp e coperti da una etichetta sconosciuta’. A tale riguardo si ritiene significativa la recente presenza a Beirut negli ambienti dell’Fplp di Carlos e si ritiene possibile che, nell’eventuale operazione in Italia, sia avocata dagli stessi autonomi e comunque da elementi non palestinesi e probabilmente europei, allo scopo di non creare difficoltà all’azione politico diplomatica in corso da parte palestinese per il riconoscimento dell’Olp e per l’auspicato invito ad Arafat“.
L’ultimo cablogramma, finora conosciuto, del 27 giugno 1980, segnalava “informazioni tarda sera Fplp avrebbe deciso riprendere totale libertà di azione senza dare corso ulteriori contatti a seguito mancato accoglimento sollecito nuovo spostamento processo (ndr, di appello davanti alla Corte dell’Aquila). Se il processo dovesse avere luogo e concludersi in modo sfavorevole mi attendo reazioni particolarmente gravi in quanto Fplp ritiene essere stato ingannato e non garantisco sicurezza personale ambasciata Beirut“.
Un mese dopo saltava in aria la stazione di Bologna.
Ma è solo un anno fa, nella fase dibattimentale del processo contro Cavallini, che emergevano alcune sconcertanti novità sepolte per 39 anni dall’incompetenza e dalla menzogna (e che solo un recente libro scritto dall’avvocato Valerio Cutonilli e dal giudice Rosario Priore avevano in parte anticipato): il rinvenimento tra le macerie, ancora conservate, di un meccanismo di sicurezza usato per il trasporto di congegni innescati; la prova scientifica della non attribuibilità di un lembo facciale appartenuto a una donna a una delle 85 vittime, Maria Fresu, cui era stata inizialmente assegnata, né a nessuna altra; la conseguente scomparsa di due cadaveri, quello della maschera facciale e quello della Fresu, essendo matematicamente impossibile una loro disintegrazione; l’estrema vicinanza di quella misteriosa persona, la cui scomparsa non è stata mai denunciata, al punto dell’esplosione capace di provocare, appunto, quello scuoiamento; la ritenuta possibilità di uno scoppio accidentale e l’estrema improbabilità di un innesco chimico, diversamente da quanto sostenuto dai precedenti periti; la presenza nella miscela esplosiva di pentrite, un detonante uguale a quello trovato in possesso due anni dopo della terrorista tedesca Christa Frolich, riconosciuta da un cameriere d’albergo come presente il primo agosto all’hotel Jolly di Bologna, legata a Carlos, raggiunto da lei e da Kram pochi giorni dopo la strage a Budapest.
Non è inoltre di poco conto la circostanza che, in alcuni servizi televisivi immediatamente successivi allo scoppio, almeno tre persone dichiararono di aver visto un cadavere senza testa. Nessuno degli 84 corpi ritrovati – vista la scomparsa di quello della Fresu – si presentava decapitato.
Aggiungiamo infine che, in un albergo bolognese situato nei pressi della stazione, fu registrata la presenza di una donna con passaporto cileno poi rivelatosi falso. Questo documento faceva parte di uno stock di altri cinque dalle caratteristiche simili, usati da Carlos e da un esponente palestinese del FPLP.
Ce n’è abbastanza per ritenere la scena del crimine totalmente diversa da quella ipotizzata dalla magistratura bolognese; diversa e inquinata. Dove sono finiti i corpi della Fresu e di quello da cui si staccò la maschera facciale?
Chi scrive non ha la pretesa di conoscere la verità sulla strage. Qualcuno ha anche avanzato l’ipotesi che chi trasportava l’esplosivo sia rimasto vittima di uno scoppio provocato ad arte da “entità” che volevano punire il nostro paese a causa di quell’accordo che tradiva le alleanze ufficiali.
Tutto può essere, ma è bene ricordare che il processo non serve a costruire o avvalorare teorie, o, addirittura la “storia”, come invece pretendono i cultori delle supercazzole teorematiche delle “forze ostili alla democrazia” e del “(loro) controllo e gestione politica (delle stragi) nell’ambito di un progetto teso al condizionamento degli equilibri politici espressi nelle forme previste dalla Costituzione”.
Il processo serve soltanto a stabilire se l’imputato è colpevole o innocente; se gli elementi di prova raccolti contro di lui forniscono o no certezza della sua responsabilità. Questa è la civiltà giuridica. Le sentenze non debbono scrivere la storia.
Anch’io non credo che chi portava l’esplosivo – la misteriosa donna di cui è rimasta solo la tragica maschera facciale? C’è da giurarci – volesse attentare alla stazione di Bologna. Per quanto feroce si sia dimostrato il terrorismo palestinese, che – non dimentichiamolo – colpì duramente anche in Italia, provocare un simile disastro per la mancata liberazione di un uomo mi sembra una rappresaglia sproporzionata, anche per il peggiore dei farabutti. È improbabile però che dopo 40 anni – spesi a inseguire le nuvole invece d’indagare seriamente – si riuscirà ad arrivare ad una corretta ricostruzione dei fatti, attribuendo con sicurezza quella carneficina ai suoi veri autori.
Quel che è certo è che sia al partito della strage fascista/anticomunista, sia allo Stato, o se si vuole al partito della ragion di Stato (quella che spinse il SISMI, che conosceva la verità, a inventare piste false contro l’estrema destra, tutta, dai NAR a Terza Posizione da Ordine Nuovo ad Avanguardia Nazionale) la menzogna continua a fare comodo.
Il primo per mantenere in piedi il teorema funzionale alla ricostruzione storico-ideologica su cui ha investito dal punto di vista giudiziario e informativo; il secondo perché non deve emergere che la strage costituì l’orrendo effetto di un accordo umiliante, per nascondere il quale ha accettato omicidio, calunnia e ingiustizia.