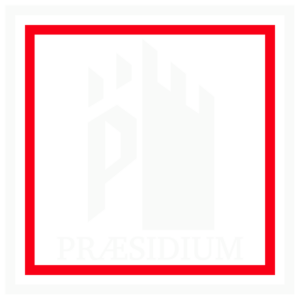“Cantavamo, morivamo, danzavamo di padre in figlio, crescendo di numero e di esperienza dell’isola. Eravamo felici. Chiamavamo noi stessi s’ard, che nell’antica lingua significa danzatori delle stelle.”
In questo singolare romanzo, finito di scrivere poco prima di morire, l’autore – sardo e notoriamente di sinistra, ma irrimediabilmente radicato in una tradizione e in una razza che lui ovviamente non aveva scelto, ma che chiaramente amava con tutto il cuore come il più ardente dei tradizionalisti – ripercorre la storia dei suoi antenati, fin dalle più remote origini mitiche e preistoriche. Occorre riconoscere che se anche il romanzo è dichiaratamente celebrativo e di parte, quasi una sorta di Eneide dell’isola, cerca anche di essere obiettivo tanto da non nascondere nulla dei lati più discutibili degli antichi sardi fin dall’inizio: “Finché fummo ventuno villaggi e per ogni gente le altre venti erano estranee o nemiche” e “A quel tempo uccidere e morire non era una tragedia per nessuno eccetto i familiari dell’ucciso che cercavano vendetta”.
Certo la parziale romanizzazione e la successiva cristianizzazione hanno contribuito all’identità sarda, l’hanno civilizzata, addolcita, completata ma non l’hanno interrotta, in un curioso incontro/scontro con Roma.
La morale del racconto può essere racchiusa tutta in una parola: tradizione. Una tradizione che per essere tale, passa incessantemente e coerentemente dai vecchi ai bambini, per generazioni, per secoli, per millenni. Tradizione che scorre col sangue, si esprime nella lingua, si fortifica nella lotta e si manifesta in usi e costumi.
Lo stesso “filo conduttore” del racconto è nelle parole che un vecchio affida a un bambino, parole che costituiscono una storia orale ma vitale e per certi versi, sacra. Parole che il vecchio ha ricevuto da altri antenati anni prima e che il bambino avrà il dovere di trasmettere a sua volta ad altri discendenti ancora nel corso della sua vita perché non devono andare perdute. Le generazioni appaiono solo anelli nella interminabile catena della stirpe che si affida fondamentalmente ai “Giudici”, garanti di una giustizia forse barbara e spietata ma rapida, efficace e pienamente condivisa dal popolo e ai “Custodi del tempo”, sorta di archivi viventi e storici popolari, depositari di una storia in versione isolana, da contrapporre a quelle “ufficiali” dei diversi invasori arrivati dal mare: etruschi, liguri, fenici, romani, greci bizantini, goti, pisani, aragonesi e infine anche savoiardi.
Notevole il trucco (peraltro facilmente smascherato) della storiografia savoiarda per disarmare la resistenza dei sardi alla colonizzazione e far loro accettare l’usurpazione del titolo di re di Sardegna. Gli storiografi e gli insegnanti savoiardi cercavano di convincere i sardi che la loro resistenza etnica e culturale era già stata spezzata più volte nei secoli e sottolineavano la discendenza dei sardi moderni dagli invasori e dagli schiavi importati. La Sardegna non doveva avere una storia propria ma solo segmenti discontinui privando i suoi abitanti di una vera identità propria. Insomma, i sardi moderni potevano essere fenici, mauri, tutto … ma non sardi! Un cavallo di Troia culturale, un inganno per disarmarli e favorire usurpatori e sfruttatori. Contro questa versione distorta mirante allo sradicamento etnico tuonavano i Custodi del tempo come Cosimo Seba che rivendicavano la continuità etnica e culturale dei sardi e respingevano le teorie strumentali e artificiose dei colonizzatori savoiardi: “In Barbaria, però, ci facevano nascere. In Mauritania, non a Alesia, non sul Reno. Negri ci facevano nascere, non bianchi”.
A ben vedere, non è forse lo stesso trucco usato spesso con tutti gli italiani vittime oggi dell’ultima invasione? Esaltare solo chi è arrivato dopo come invasore o schiavo, per rinnegare la discendenza più antica e tagliare le radici più profonde dei popoli italici originari: etruschi, celti, latini, greci, umbri, sabini, osci, veneti, sanniti, siculi e … sardi! La sovversione non tollera la tradizione! La odia. Deve spezzare la storia di un popolo per vincere la sua resistenza.
A lettura conclusa, verrebbe spontaneo muovere una critica tecnica all’autore, Sergio Atzeni, e alla curatrice, Giovanna Cerina: la mancanza di una mappa della Sardegna antica coi nomi arcaici riportati nel testo del romanzo. Certo, avrebbe fatto comodo ma a ben vedere, un vero sardo sarà perfettamente in grado di orientarsi anche senza una mappa e allora, deve forse aver pensato Atzeni con un sorriso … perché favorire i lettori continentali?
Un compito veramente impossibile per il lettore è quello di districare chiaramente i tre filoni che si intrecciano e mescolano di continuo: quello storico propriamente detto cioè verificabile o comunque ufficiale, quello leggendario trasmesso oralmente e che agisce sul piano mitico, e infine quello romanzesco aggiunto o rielaborato dall’autore a fini narrativi e dunque più soggettivo e fantasioso. Del resto, se è difficile districarli nelle opere omeriche per quale motivo dovrebbe essere più facile in questo romanzo? In fondo, il fatto determinante e costante è quello di una identità meravigliosa e misteriosa, antica ma viva che si rifiuta di sparire e di arrendersi, e che oggi, nell’era del mondialismo e delle migrazioni-invasioni di massa, dovrà presto affrontare la prova più dura della sua lunga storia.