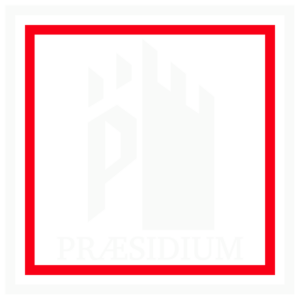Nell’anno 472 a.C., ad Atene, viene messa in scena la tragedia di Eschilo (525 a.C. – 456 a.C.) intitolata “I Persiani”, la più antica opera teatrale pervenutaci per intero. Ad un certo punto ecco la domanda angosciante, drammatica, attuale: “Infinito è il grido di dolore che sale dalla terra verso il cielo; ci sarà mai un dio che l’ascolterà dal segreto dell’ombra?”.
È il grande dilemma dell’uomo di fronte al “divenire che divora l’essere”, all’impotenza, alla morte. Ed Epicuro, nel frammento numero 347, rincara la dose: “Se Dio può tutto, perché il male degli innocenti?”. Da qui il noto “teorema epicureo”: o la divinità vuole abolire il male ma non può farlo, con la conseguenza che Dio sarebbe buono ma impotente, oppure può evitare il male ma non vuole (Dio, allora, sarebbe cattivo) o, infine, la divinità può e vuole evitare il male, ma non lo fa perché si disinteressa dell’uomo, è indifferente alle sue vicende.
La risposta negativa presupposta da Eschilo e l’indifferentismo di Epicuro non soddisfano le esigenze della nostra ragione, capace di follie, di superare l’uomo stesso (pensiamo al transumanesimo di cui l’emergenza sanitaria è un momento, una tappa), ma non è idonea a trovare un senso al dolore innocente del mondo. La Sacra Scrittura, in particolare la “letteratura sapienziale”, osa, invece, l’inosabile: mettere sotto accusa la stessa giustizia di Dio.
Il capolavoro poetico del libro di Giobbe è, da questo punto di vista, paradigmatico: diversamente dal pensiero filosofico greco, il protagonista del racconto stende l’atto di accusa verso Dio. Paul Claudel (1868-1955), nella sua monografia sul libro di Giobbe, si chiede quale personaggio biblico abbia mai assunto un atteggiamento al limite della blasfemia verso Dio. Giobbe ama Dio e proprio per questo non si accontenta delle spiegazione dei teologi del suo tempo, degli amici che vanno a consolarlo, di coloro che difendono Dio ad oltranza tradendo così le aspettative di chi è seduto sui letamai dell’umana sofferenza. Dio non ha bisogno di chi lo difende, ma di essere liberato dalle prigioni concettuali dove spesso viene rinchiuso.
La risposta di Dio non è razionale ma esperienziale: prende Giobbe per mano e gli fa fare semplicemente un’esperienza di verità su di sé. Giobbe è così aiutato da Dio a misurarsi sulla sua realtà di uomo, di uomo che non sa nulla della vita, e quindi non sa nulla della sofferenza e della morte. Dio non inchioda Giobbe brutalmente alla sua limitatezza, ma con dolcezza, nella meraviglia e nello stupore, lo aiuta a riconciliarsi con la verità: “Dov’eri tu quando ponevo le fondamenta della terra?”. Neppure il cristianesimo elabora una “teoria del dolore”, ma, diversamente da altre fedi, cerca di dare un senso al non senso, cerca di testimoniarci perché il Dio che si é fatto carne e sangue ci ha salvati, ma non ci ha liberati dalla morte fisica.
La vera risposta, silenziosa, che Dio dà alle nostre domande, è Cristo nato, morto e risorto. Gesù non si preoccupa di spiegarci il motivo di queste realtà umane, ma vive in sé tutti i dolori del mondo e li accetta, vincendo la morte e oltrepassandola con i “segni stessi della passione”. Chi ha un Dio così… che, nella notte nera, sopra la pietra nera, è l’unico che vede ed ama la formica nera che vi si trova sopra.