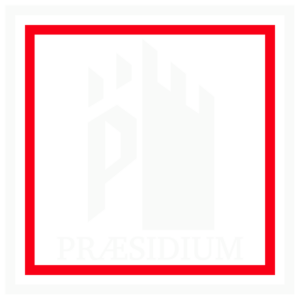Il 14 giugno del 1928 nasceva a Rosario – Argentina – Ernesto “Che” Guevara de la Serna.
Quel che rimane di lui è un’immagine stampata su milioni di magliette. Si è trasformato in un marchio, un business del mercato capitalista, esibito da milioni di persone, la stragrande maggioranza delle quali ignora il suo pensiero, i suoi sentimenti, le sue azioni.
Il suo odio prima di tutto.
“L’odio come fattore di lotta, l’odio intransigente verso il nemico, che stimola molto al di là delle limitazioni naturali dell’essere umano e lo trasforma in una efficiente, violenta, selettiva e fredda macchina di morte. I nostri soldati debbono essere così: un popolo senza odio non può trionfare su un nemico brutale”; questo il messaggio che mandò all’assemblea della OLAS (Organización Latina-americana de Solidaridad), creata in occasione dell’assemblea della TRICONTINENTAL dell’anno precedente, radunatasi a Cuba nell’estate del 1967, mentre lui, nelle sierre della Bolivia, consumava il suo rancore verso il mondo, immerso com’era in un’atmosfera da incubo, lottando contro la natura e l’ostilità dei contadini Quechua che non ne volevano sapere della sua revolución.
Provò amore, a modo suo, solo per sua madre, che lo riamò perdutamente; e cieca attrazione verso le proprie utopie che finivano per confondersi col suo ego narcisista, volto al rifiuto di ogni civilizzazione organizzata che non fosse concepita come diceva lui.
Per il resto egli fu un negatore, un Satana, appunto; non costruì mai nulla, ma distrusse tutto quello che incontrò: l’economia cubana, con la sua l’idea di espiantare la canna da zucchero “prodotto colonialista” (perché in gran parte esportato negli Stati Uniti che anche in tal modo esercitavano una notevole influenza su Cuba), vagheggiando l’industrializzazione dell’isola che mai si realizzò; e poi le vite umane, giustiziando personalmente alcuni contadini accusati di tradimento nella Sierra Maestra e poi alla Cabaña – il fortino militare situato nel porto dell’Avana – quando fungeva da giudice, pubblico ministero e giudice d’appello, assistendo anche alla fucilazione di tanti condannati per incoraggiare, con la sua presenza, coloro che all’interno dei plotoni d’esecuzione avevano meno stomaco di lui.
Della vita umana egli non tenne mai alcun conto, né quella dei suoi avversari ma neanche quella dei suoi uomini e neppure la sua, che immolò in una specie di suicidio annunciato e forse alla fine cercato.
Il suo odio (iscritto, se vogliamo, in uno stampo romantico ma sempre di odio si trattava) esportato in quasi tutti i paesi della regione, si trasformò in caos, lutti e più miseria. Tutto inutile per i popoli che volevano affrancarsi dalla povertà e che erano stati illusi dalle utopie della Guerra de Guerrillas che prometteva loro destini radiosi.
Non amò Cuba, patria adottiva dopo la vittoria castrista, troppo ruffiana e fanfarona per lui, che vagheggiava un “uomo nuovo” tutto lavoro, marxismo-leninismo, disinteresse, rifiuto-del-benessere; né amò la sua patria natale, l’Argentina che progettò d’invadere ed infiammare due volte, mandando allo sbaraglio prima l’amico Jorge Ricardo Masetti nel 1964 poi se stesso e i suoi miliziani nella fatale spedizione boliviana del 1966/1967.
“Appartengo per la mia preparazione ideologica a coloro che credono che la soluzione dei problemi del mondo si trova dietro la così detta cortina di ferro” così egli scrisse alla fine del 1957, dalla Sierra Maestra, in polemica con gruppi anti-batistiani cittadini che però erano nella stragrande maggioranza anti-comunisti; e che lui, naturalmente, per questo disprezzava nonostante l’enorme tributo di sangue da loro versato (ben più di quello costato a Castro e ai suoi, rintanati sulle montagne) per la causa comune.
Poi anche il suo entusiasmo per l’URSS sfumò e nel suo cuore non rimasero che frustrazione e odio. Che forse si dissolsero negli ultimi minuti della sua vita, la mattina del 9 ottobre 1967, quando, prigioniero dell’esercito boliviano in una stanza della scuola del paesino di La Higuera, capì che di lì a poco gli sarebbe toccata la stessa sorte che lui otto anni prima aveva riservato a centinaia di reclusi, condannati al paredón, anche sulla base del solo sospetto, da uomini che avevano perduto ogni senso di pietà.
Forse si ricordò anche del diciassettenne Ariel Lima, arruolatosi nel Movimiento 26 Julio e poi accusato di tradimento, avendo riferito alla polizia, sotto tortura, notizie su uno spostamento di guerriglieri durante la lotta rivoluzionaria, che aveva portato alla morte di due di loro.
Dopo il processo di appello, durato poco meno di mezzora, che confermava il verdetto di morte, fuori dagli uffici dove era stato appena sbrigato il macabro incombente, “Che” Guevara incontrò una donna che si gettò ai suoi piedi.
In quel momento con lui si trovava il sacerdote Javier Arzuaga che cercava di convincerlo a concedere la grazia al ragazzo. Informato che si trattava della madre del giovane, il “Che” si rivolse freddamente a lei con queste parole: “Le raccomando di parlare con padre Javier, è un maestro per le consolazioni”, poi guardando il sacerdote che lo accompagnava, con un tono beffardo gli disse: “É sua”.