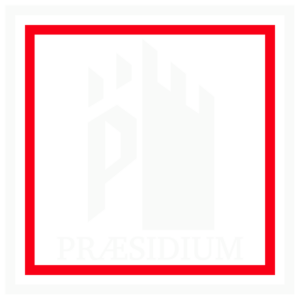Viviamo nella società della pretesa “autenticità”.
Tutto intorno a noi è una costante ed ossessiva esortazione ad “essere noi stessi”, eventualmente anche a scapito del prossimo.
Ma, come scriveva argutamente Nicolás Gómez Dávila
“l’idea del “libero sviluppo della personalità” sembra degna di ammirazione finché non si incappa in individui la cui personalità si è sviluppata liberamente.”
Il noto filosofo cattolico Gustave Thibon, già nel 1974 in un articolo intitolato “Réhabilitation de la politesse”, denunciava lo smarrimento della cortesia, quell’insieme armonioso di piccoli ed apparentemente inutili gesti gentili che possono migliorare o quantomeno alleviare, gratuitamente, la giornata di chi li riceve; quelle beneducate frivolezze rimpiante da Talleyrand quando scriveva che “chi non ha vissuto negli anni prima della Rivoluzione non può capire che cosa sia la dolcezza del vivere”.
Scriveva Thibon, nell’articolo summenzionato:
“Diciamo piuttosto che viviamo in un clima di tensione nervosa e dispersione psicologica poco favorevole, a ogni età, allo sbocciare di quel fiore delicato che è la cortesia”.
Da allora lo stato di questo nobile atteggiamento dell’animo è tutt’altro che migliorato, anzi se ne è avverato un lento e continuo deterioramento.
Gli artefici del 68’, i quali hanno procurato ai costumi i medesimi danni che gli artefici dell’89’ francese causarono alla politica e alla religione, non potevano che educare i loro figli ad una sottomissione totale nei confronti dei loro più bassi istinti. Tale sottomissione all’io bestiale viene nobilitata, attraverso il linguaggio distorto degli ultimi decenni, nel nome della sincerità e dell’autenticità, come accennato in esordio.
Chiunque rispetti ancora i precetti morali che per secoli ressero la civiltà, i tradizionali rituali del buon costume sociale, viene accusato di ipocrisia e fariseismo. Basti pensare all’accezione negativa, ormai universalmente condivisa, riservata all’espressione “convenzione sociale”.
Viviamo in un mondo intellettualmente totalitario e limitante, ma guai a conservare qualche buona abitudine soltanto perché “si deve”. Bisogna sentire l’ispirazione interiore, essere appagati, avvertire lo slancio emotivo.
Tutto ciò che è precetto deve perire. Rispondeva così Thibon ad un “giovane emancipato” che gli chiedeva se non fosse ipocrita sorridere in treno allo sconosciuto il cui aspetto non ci garba o ascoltare pazientemente le storie di un vecchio ritenuto noioso:
“Non sono sincero con la mia ghiottoneria quando, seduto a una buona tavola, rifiuto di concedermi un supplemento del piatto che mi fa gola. Ma lo sono con la mia volontà che mi comanda di resisterle. Lo stesso vale per gli sconosciuti incontrati in treno: se nel mostrare loro cordialità non sono coerente con i miei umori nondimeno mi sento perfettamente in sintonia con un imperativo più profondo: quello che mi intima di comportarmi umanamente con tutti gli uomini.”
Mi permetto di aggiungere che foss’anche una cortesia ipocrita, magari imposta per imperio genitoriale o da interesse personale, essa risulterebbe meno nobile ma ugualmente benefica e comunque preferibile ad una “autentica” maleducazione.
Ma l’artificiosità di tale argomentazione poi, la si riscontra nell’incapacità moderna di essere cortesi anche laddove esserlo converrebbe all’emittente più che al destinatario. Penso, senza voler generalizzare, alla spaventevole quantità di addetti al commercio inabili persino al sorriso e talvolta finanche al saluto.
Evidentemente neanche l’ipocrisia interessata è più in grado di smuovere l’empatia incancrenita dell’uomo contemporaneo.
Un tempo l’empatia, madre della cortesia, si praticava naturalmente e spesso senza averne contezza, poiché si conoscevano le leggi di natura oltre che quelle evangeliche:
“Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro” (Nostro Signore Gesù Cristo nel discorso della Montagna).
Oggi invece facciamo un gran parlare di empatia, la studiamo, ne discutiamo nei corsi di psicologia, nelle scuole, nei colloqui di lavoro, ma essendo troppo impegnati a disquisirne, non abbiamo più il tempo di praticarla. Alle denunce dei falsi profeti di una distorta sincerità, i quali accusavano ed accusano i cultori della cortesia, considerata retaggio di un mondo antico e destinato a scomparire, di curare esclusivamente l’esteriorità dell’uomo, Thibon si oppose, e noi con lui seguendone le orme, argomentando che un corretto atteggiamento esterno, nel lungo termine, leviga l’anima e lo spirito:
“Uno dei nostri grandi moralisti francesi riassume così la questione: La cortesia non implica sempre la bontà; essa ne da almeno l’apparenza e fa apparire l’uomo all’esterno come dovrebbe essere all’interno. Ma c’è dell’altro: lo aiuta a divenire interiormente come egli si presenta esteriormente. La nostra epoca, così pronta a disprezzare le convenzioni esteriori in nome di una pseudo-profondità che si riduce il più delle volte ai moti anarchici degli umori e delle pulsioni, disconosce un fenomeno comune a tutte le forme di disciplina e di educazione: i gesti e i segni più convenzionali impregnano poco alla volta l’essere interiore. Sapersi giostrare adeguatamente nel gioco sociale porta ad assimilare le regole del gioco. In altre parole l’abito, malgrado quel che dice il proverbio, esercita sempre qualche influenza sull’anima del monaco e così, a forza di “salvare l’apparenza”, finiamo per modificare positivamente la realtà.”
Il filosofo contadino, in conclusione, definì la cortesia come “la forma epidermica e anonima dell’amore per il prossimo”.
Una società che non sa amare non può essere cortese e la nostra non solo non sa amare, nonostante sia strabordante di insulsa mielosità, ma non conosce cosa sia l’amore, avendolo confuso con la liberalizzazione degli istinti da un lato e col dolciastro buonismo dall’altro. La cortesia non è simile allo sporchevole zucchero a velo, bensì alla fresca brezza marina.
È una predisposizione d’animo che regge l’equilibrio dell’universo e innanzi alla quale valgono ancora quelle antiche e vituperate gerarchie della vita nelle quali, ad esempio, all’anziano sono riservate maggiori attenzioni che al giovane, alla donna più dell’uomo, ma ella medesima è chiamata poi a praticare una cortesia femminea degna del gentil sesso.
Se riabilitassimo la Cortesia avremmo un mondo maggiormente ordinato e regaleremmo qualche sorriso in più all’anonimo sconosciuto.
Le buone maniere e l’etichetta, valgono ancor più quando praticati nei confronti degli avversari o dei nemici. Un animo nobile sa modulare la rigidità e la fermezza nella battaglia- spirituale, culturale, politica o militare che sia- con l’eleganza della cortesia. A tal proposito si rende opportuno concludere citando una pagina del celebre romanzo “I Centurioni” di Jean Lartéguy:
“Era passato il tempo in cui il vincitore presentava le armi alla guarnigione vinta che si era battuta bene. Non c’era più posto per la cavalleria degli uomini di guerra e per le sue ultime vestigia. Nel mondo gelido del comunismo, il vinto era un colpevole ridotto al rango di un qualsiasi condannato di diritto comune. Nell’aprile 1945, i principi della casta resistevano ancora. Il sottotenente de Glatigny comandava allora un plotone di ricognizione davanti a Karlsruhe. Aveva catturato un maggiore tedesco e l’aveva scortato dal comandante di squadrone, de V…, che era anche suo cugino e apparteneva alla stessa razza militare di signorotti di campagna, volta a volta predatori di pellegrini, crociati, connestabili del re, marescialli dell’Impero e generali delle repubbliche. Il comandante di squadrone aveva installato il posto di comando in una foresteria. Era uscito incontro al prigioniero. Si erano salutati e presentati. Anche il maggiore portava un nome importante nella Wehrmacht e si era ben battuto. Glatigny era stato colpito dalla somiglianza tra i due uomini: gli stessi occhi penetranti incassati nelle orbite, la stessa elegante rigidità del gesto, le labbra sottili, il naso forte e aquilino. Senza rendersi conto che anche lui somigliava a loro… Era di mattina molto presto. Il maggiore V… invitò Glatigny e il suo prigioniero a colazione con lui. Il tedesco e il francese, a loro agio perché si ritrovavano tra persone della stessa casta, cercarono di immaginare tutte le località dove, dal 1939, avevano potuto battersi l’uno contro l’altro. A loro importava poco che l’uno fosse il vincitore e l’altro il vinto purché fossero state rispettate le regole e si fossero ben comportati. Tra loro correva della stima e, potenzialmente, anche dell’amicizia. De V… fece accompagnare il maggiore al campo di prigionia con la sua jeep e prima, di lasciarlo, gli strinse la mano. Glatigny fece altrettanto.”