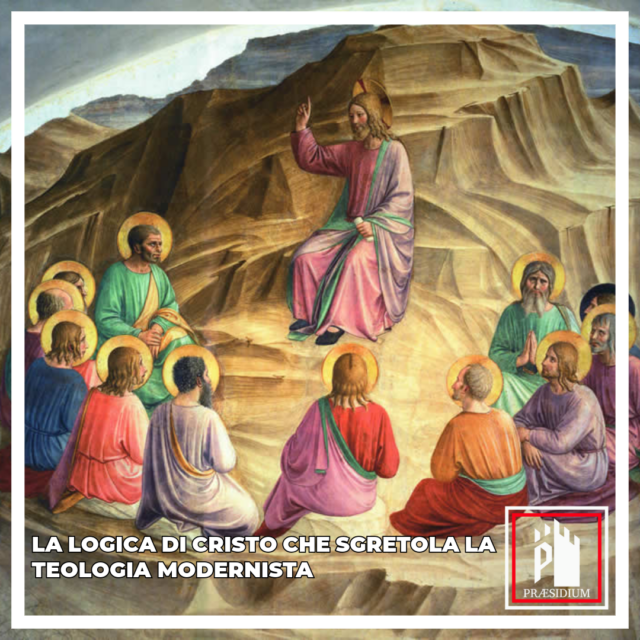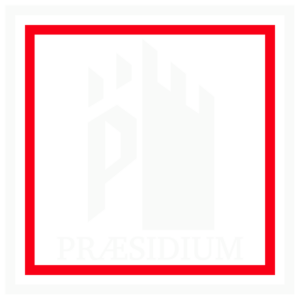Il modernismo fornisce interpretazioni nuove e stravaganti della teologia, della dottrina, e della filosofia cattolica.
Possiamo dire senza ombra di dubbio che molti studiosi provano da decenni a cambiare “Roma con Roma” come intendeva Bonaiuti, tentando di far rientrare Dio dentro i loro canoni di pensiero.
Nonostante l’intera tradizione cattolica rimane coerente nei secoli di questi tempi però permane una forte confusione nel pensiero religioso, quindi per capire meglio la filosofia cattolica perché non guardiamo i Vangeli e ci soffermiamo sul pensiero di Gesù?
La prima cosa che notiamo è che Cristo si classifica all’interno della filosofia dell’essere, infatti il suo riferimento è esplicito nel vangelo di Giovanni «In verità, in verità io vi dico: prima che Abramo fosse Io Sono» (Gv 8,58); in un dialogo serrato di fronte ai suoi interlocutori fa capire di Essere ed esserci dal principio, ma queste parole sono ancora più chiare in questi versi: «Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo – dice ancora agli stessi – allora conoscerete che Io Sono» (Gv 8,28).
Questi riferimenti sono collegati all’antico testamento in modo chiarissimo, infatti Mosè chiede a Dio una definizione di sé che risponde così (Es 3,14-16): «Dio disse a Mosè: “Io sono colui che sono”. E aggiunse: Così dirai agli Israeliti: “Io sono mi ha mandato a voi”… Questo è il mio nome per sempre; questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione».
C’è un’omologia tra antico e nuovo testamento, e partendo da questa piccola considerazione possiamo “scartare” tantissimi filoni di pensiero moderni che contemplano la vittoria del pensiero sull’essere, o la vittoria del non-essere, ma c’è ancora di più, nei Vangeli Cristo ragiona con il principio di non contraddizione, agganciato sempre alla filosofia dell’essere e al pensiero classico: «Nessun servo può servire a due padroni: o odierà l’uno e amerà l’altro oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire a Dio e a mammona» (Lc 16,13).
Il suo modo di parlare alle folle inoltre ci indica una cosa molto chiara, per il Rabbì, la conoscenza della realtà parte dal fenomeno per arrivare al noumeno tramite il criterio di analogia, questo modo di intendere il reale è collegato a una filosofia realista e a un pensiero che non esclude le varie percezioni soggettive ma reclama una conoscenza universale del fenomeno, tutto questo è molto chiaro quando descrive il regno dei cieli: il buon seminatore, il lievito, il granello di senape, il banchetto di nozze, la lampada sono tutti insegnamenti che partono da una conoscenza concreta del reale, che per analogia ci porta a comprendere l’universale.
Non si esclude in nessun modo l’impressione particolare, ma si riconosce come tramite il fenomeno si può risalire al noumeno (contrastando in particolar modo Kant).
C’è anche di più, nei suoi insegnamenti la comprensione antropologica, etica, e psicologica dell’uomo partono a loro volta in modo inverso, ovvero dall’universale al particolare: comprendere Dio ci fa comprendere l’uomo che altrimenti resta un mistero a sé stesso ed è destinato a “perire”.
La parte etica è chiara quando risponde risponde al giovane ricco che lo definisce “buono” (Mc, 10,17), per Lui la bontà non si autodefinisce in una scala parziale e relativa, bensì si ricava dal vero volto di Dio: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non uno solo, cioè: Dio».
Questa tesi si incastra con il peccato originale perchè Adamo vuole scavalcare con superbia il Creatore tentando di definire e circoscrivere in modo artificiale il bene e il male, mangiando il frutto infatti pensa di essere l’ultimo legislatore sulla realtà (seguendo la tentazione) rivelandosi poi un fallimento.
In antropologia la parabola della vite e dei tralci si collega ai moniti di Dio rivolti al popolo ebreo di perire di fronte all’apostasia e spiega chiaramente come l’uomo non trova la sua forma vitale se non si innesta nella vite, senza di Dio si vive solo lo stato “animale” (1) ed orizzontale e la popolazione non porta frutto come nel caso del fico.
Ho parlato anche di psicologia, perché effettivamente nel Vangelo di Luca, vediamo che Dio si confronta con un dottore della legge riguardo alla vita eterna, che non era intesa anticamente come la semplice immortalità, ma era vista anche come una vita “buona”, oggi potremmo definirla come “una vita degna di essere vissuta”, e Cristo risponde al suo interlocutore evidenziando che la vita “piena” risiede proprio nell’amare Dio con tutte le forze e poi nell’amare l’uomo.
Dove la fonte del Bene e dell’Essere vengono toccati si crea il Benessere di tutto l’uomo.
C’è un altro scorcio importante nella filosofia di Gesù, che è quello del terzo escluso, nel Vangelo di Matteo l’invito di Cristo è di parlare con franchezza, e a sapersi rilegare al “si” e al “no”, senza doppi fini, e senza sfumare le condizioni oggettive in termini di dottrina.
Chi è onesto non ha bisogno di sofismi, e neanche sente l’esigenza di alterare la realtà, o di ribaltare le condizioni oggettive delle situazioni.
Questo non significa non comprendere anche la parte soggettiva, piuttosto in questo insegnamento il Rabbì non vuole che il parlare diventi un discorso dove regnano gli opposti e l’incoerenza.
Ancora di più in Cristo l’essere precede l’azione, perché se siamo malati internamente non possiamo avere una visione chiara delle cose (Mt, 6,22) ecco perché il nostro modo di vedere le cose coincide con la nostra rettitudine, tutto questo è anche esplicito in Marco (7,14-23) da ciò che è realmente l’uomo escono azioni intenzioni e conseguenze, tutto ciò si ricongiunge con l’antico testamento dove Dio chiede agli uomini una continua conversione di cuore (si veda Gioele e i tanti profeti) per renderli puri nella loro essenza.
Un’ultima analisi va fatta sull’evento Cristiano, dove Dio viene totalmente a coincidere in potenza ed atto, in essenza ed esistenza, lasciando in disparte sia il puro esistenzialismo, sia la semplice essenza del “demiurgo” che non si manifesta nell’immanenza.
(1) S. Paolo nelle sue epistole tratterà in modo particolare il tema arrivando a spiegare come vivere in Cristo porta ad un cambio antropologico