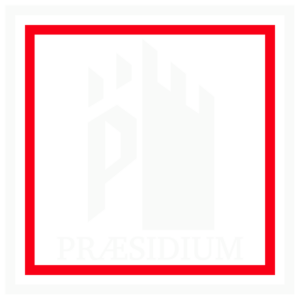Il sindacato, inteso come una forma di organizzazione per la difesa dei diritti dei lavoratori, di diversa provenienza ideologica (CGIL, storicamente vicino all’ ex PCI, CISL, il sindacato d’ispirazione cattolica, UIL, vicino all’ ex PSI e l’UGL, l’ex CISNAL, che è la stata la confederazione sindacale contigua al Movimento Sociale Italiano e le altre sigle minori autonome), non esiste praticamente più nella società globalizzata perché il lavoro non è completamente tutelato da chi formalmente si dichiara dalla parte di essi ed è divenuto uno strumento politicizzato manovrato dai grandi partiti di massa.
Uno dei più importanti sindacalisti che è vissuto brevemente tra fine del XIX secolo e l’inizio del XX è stato Filippo Corridoni.
Le prime esperienze sindacali a Milano
Nato il 19 agosto 1887 a Pausula, in provincia di Macerata, giunge giovanissimo a Milano come disegnatore meccanico, milita nelle file del Partito Socialista Italiano e svolge propaganda antimilitarista.
Del capoluogo lombardo scrisse:
«Milano è una delle poche città d’Italia che è ricca di tutte le caratteristiche necessarie ad un completo trionfo delle nostre idealità: industrialismo sviluppatissimo, contrasti di classe netti e vivi, nessuna infatuazione elettoralistica, accentuato spirito battagliero, fusione completa tra indigeni e immigrati e quindi nessuna acredine regionalistica: purtuttavia il riformismo – e cioè: l’armonia fra le classi, l’intrigo piccolo borghese e bottegaio, il cretinismo schedaiolo, la repugnanza per qualsiasi lotta che potrebbe accentuare la lotta di classe a detrimento della pace sociale e quindi dell’iride elettorale – da dieci anni vi ha regno incontrastato, e, proprio a Milano, è riuscito ad esercitare i suoi più malsani esperimenti.»
Costretto a riparare in Francia, rientra in Italia nel 1908 e partecipa alle lotte contadine a Parma.
In seguito, ritorna a Milano, dove intensifica la sua azione e la lotta tra le file dei lavoratori. Si traferisce a Bologna ed è di nuovo a Milano per organizzare gli scioperi del 1913.
Corridoni è stato un oratore straordinario, un acuto e polemico articolista, entra ed esce dal carcere meneghino di San Vittore una trentina di volte.
Ammalato di tisi, picchiato brutalmente dalla polizia, stremato da una vita condotta esclusivamente alla causa dei lavoratori, principalmente i più umili – contadini e operai – diviene un punto di riferimento per il sindacalismo rivoluzionario.
La svolta interventista
Uscito dal carcere il 5 settembre 1914 sposa la causa della guerra contro l’Impero austro ungarico e insieme ad Alceste De Ambris, Cesare Battisti, Leonida Bissolati, Enrico Corradini, Filippo Tommaso Marinetti, Giovanni Papini, e Benito Mussolini diventa capo dell’interventismo sindacalista, socialista, anarchico e repubblicano.
Il 5 ottobre dello stesso anno viene fondato il Fascio Rivoluzionario d’Azione Internazionalista che è un manifesto programmatico e politico steso da sindacalisti rivoluzionari e interventisti appartenenti all’ Unione Sindacale Italiana.
Si asserisce l’utilità della prima guerra mondiale come momento storico indispensabile allo sviluppo di società più avanzate in senso politico-sociale.
Il manifesto avrà una sua applicazione politica nel Fascio d’Azione Rivoluzionaria.
Benché malato si arruola volontario quando l’Italia decidere di combattere la Grande Guerra.
Muore il 23 ottobre del 1915 in un assalto alla mitica trincea delle Frasche.
Il suo corpo non verrà mai più ritrovato.
Antifascisti e fascisti se ne contenderanno poi la memoria.
Risultò profetica la sua affermazione:
«Morirò in una buca, contro una roccia o nella corsa di un assalto ma, se potrò, cadrò con la fronte verso il nemico, come per andare più avanti ancora!»
La Società Editrice Barbarossa ha avuto il merito di pubblicare l’opera omnia corridoniana in 3 volumi nella Collana Labor:
1) «…come per andare più avanti ancora…»
(Scritti sindacali, politici, autobiografici).
2) «…per le mie idee…»
(Lettere, frammenti epistolari, cartoline dal fronte)
3) «…il fuoco sacro della rivolta…»
(Articoli di giornale).
Diretta da Andrea Benzi, Labor si propone la pubblicazione dei testi del sindacalismo rivoluzionario e del sindacalismo nazionale fascista.
Alla luce dell’attuale situazione del mondo del lavoro, con particolare attenzione a quello dipendente o precario, ma anche autonomo e piccolo imprenditoriale, operaio e impiegatizio, essa si intende di riproporre analisi e le esperienze culturali che si sono prodotte circa un secolo fa, individuando nell’oggi gli stessi presupposti che resero possibili e necessarie le lotte di allora, prima fra tutti i radicali mutamenti delle strutture produttive creati dall’affinarsi delle nuove tecnologie, i riflessi economici e sociali ed ambientali che vennero a crearsi, nonché i mutamenti politici che si determinarono.
L’ultimo volume di scritti pubblicati dalla casa editrice di Saluzzo, nota per aver dato luce alla rivista Orion, è:
«…il fuoco sacro della rivolta…» raccoglie in volume una larga parte della produzione giornalistica corridoniana, apparsa, tra il 1907 e il 1922, su: “L’internazionale”, “La conquista”, “Gioventù socialista”, “L’avanguardia” e il mussoliniano “Il Popolo d’ Italia”.
Figlio di Enrico, operaio in una fornace, si formò sulla cultura umanistica delle opere di pensatori italiani e stranieri quali: Carlo Pisacane, Giuseppe Mazzini, Karl Marx e, più tardi, di Georges Sorel.
Nel 1931 il Duce ribattezza Pausula – cittadina di 15.000 abitanti – in Corridonia e il Regime fascista fece erigere diversi monumenti in onore dell’eroe di guerra e rivoluzionario marchigiano.
Benito Mussolini sul “Popolo d’Italia” del 27 ottobre 1917 scrisse:
«Egli era un nomade della vita, un pellegrino che portava nella sua bisaccia poco pane e moltissimi sogni e camminava così, nella sua tempestosa giovinezza, combattendo e prodigandosi, senza chiedere nulla. Leviamoci un momento dalle bassure della vita parlamentare; allontaniamoci da questo spettacolo mediocre e sconfortante; andiamo altrove col nostro pensiero che non dimentica; portiamo altrove il nostro cuore, le nostre angosce segrete, le nostre speranze superbe, e inchiniamoci sulla pietra che, nella desolazione dell’Altipiano di Trieste, segnò il luogo dove Filippo Corridoni cadde in un tumulto e in una rievocazione di vittoria.»
Curzio Malaparte ebbe a dire dell’agitatore:
«I precursori e gli iniziatori del fascismo sono quelli stessi, repubblicani e sindacalisti, che avevano per primi sollevato il popolo contro il socialismo deprimente e rinnegatore ed avevano voluto ed attuato, con Filippo Corridoni, gli scioperi generali del 1912 e del 1913.»
Inoltre Corridoni appoggiò Benito Mussolini, il movimento interventista e molte delle sue idee, mediate da De Ambris e dalla dannunziana Carta del Carnaro, ispirarono la Terza via economica del fascismo – tra liberalcapitalismo e bolscevismo – (come l’idea di socializzare gli utili, attuare la cogestione delle imprese, e il corporativismo) e l’idea di rivoluzione fascista.
Filippo Corridoni è caduto oltre un secolo fa, nel 1915, per la causa degli oppressi, degli sfruttati e dei più umili lavoratori, ma il suo pensiero è ancora attuale per la società e l’Italia di domani.