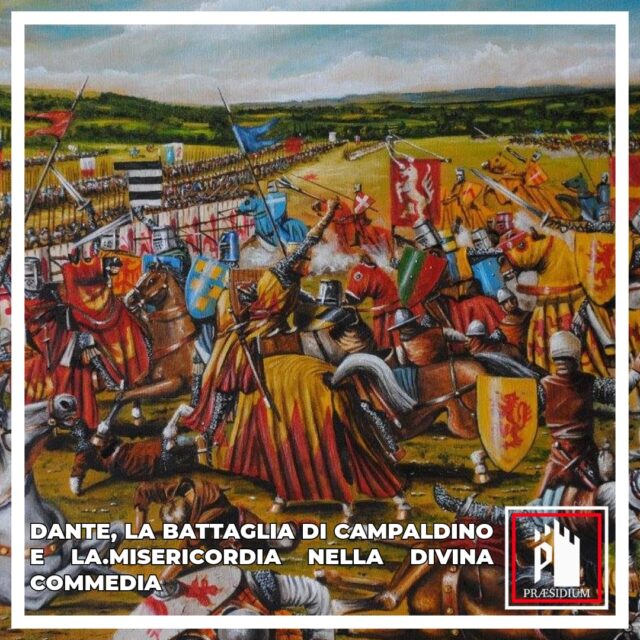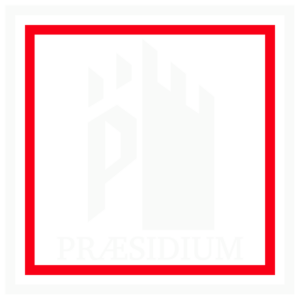Dante, la battaglia di Campaldino e la Misericordia nella Divina Commedia: Un breve spunto per chi vuol sapere.
Ad attestare la presenza di Dante Alighieri in quell’11 giugno 1289 a Campaldino sono innanzitutto i versi iniziali del XXII Canto dell’Inferno: il primo verso “Io vidi già cavalier muover campo” e poi tra il quarto e il quinto “corridor vidi per la terra vostra/o Aretini”, ma è anche una testimonianza tarda ma attendibile: quella di Leonardo Bruni, letterato aretino vissuto tra 1370 e 1444, che riporta la nota lettera scomparsa in cui Dante scriveva di aver provato “temenza molta”.
La fifa di Dante
Si è molto scherzato su questa “temenza” del giovane Dante. Probabilmente perché spesso non si legge il seguito della lettera dove Dante scrisse: “Ebbi temenza molta e nella fine allegrezza grandissima per li vari casi di quella battaglia”.
È solo leggendo la frase per intero che scorgiamo la preoccupazione per l’ esito della battaglia e le sorti della sua Firenze, oltre alla naturale paura e all’umano sollievo per aver avuta salva la vita nella vittoria.
È poi nei versi che vanno dal 91 al 129 del V Canto del Purgatorio che Dante narra la vicenda della morte di Bonconte da Monte da Montefeltro, che combatté con gli Aretini dalla parte ghibellina. Né mancano descrizioni assai crude degli effetti delle armi sui partecipanti alla battaglia. Sono i versi 22-27 del Canto XXIII dell’inferno. Ricordiamo i più noti e forse meno truculenti: “rotto dal mento infin dove si trulla/tra le gambe pendevan le minugia”.
Certo, si fa fatica a immaginare Dante in battaglia. Ma aveva ventiquattro anni e svolgeva il suo ruolo di “feditore”, cioè di cavaliere incaricato di portare un primo attacco agli avversari, indossando a cavallo la cotta di maglia con la sopravveste e forse in capo il tipico elmo integrale del XIII secolo, comunemente associato ai Templari, che consentiva una assai ristretta visuale. Tutto a spese sue.
La sua famiglia, non ricchissima, era però abbastanza benestante da consentirgli di studiare e di vivere di rendita, oltre che a mantenere lo status che gli consentiva di prendere parte alle attività politiche e militari della città, portandolo poi a ricoprire la carica di priore verso la metà dell’anno 1300.
Sarà quella carica l’origine dei suoi guai. Ma, come ben sappiamo, furono proprio quei guai che, sulla base del suo genio e dei suoi profondi studi letterari e dottrinali, a farlo diventare quel che divenne.
Nonostante Beatrice Portinari fosse il suo “senhal”, cioè la donna amata simbolica, mediatrice tra l’umano e il divino, Dante aveva sposato Gemma di quei Donati di antica nobiltà a Firenze e ai tempi di Campaldino era già sposato da quattro anni, dopo otto di fidanzamento e già padre di Jacopo, che aveva poco più di tre anni.
Quella giornata, inizialmente assai secca e tersa, dell’ 11 giugno 1289, vide in serata la sia pur difficile vittoria della parte guelfa, costituita dai Fiorentini e dai loro alleati, al comando di Amerigo di Narbona, sulla parte ghibellina, cioè gli Aretini e i loro alleati, guidati dall’anziano e miope vescovo della città, Guglielmino degli Ubertini, perito in combattimento.
La vittoria fiorentina segnò un importante ulteriore passo nella conquista dell’egemonia della città sulla Toscana.
In serata si scatenò un violentissimo temporale, che provocò la piena dei corsi d’acqua che, come il torrente Archiano e il fiume Arno scendono dall’Appennino.
E il corpo di Bonconte si trovava, narra Dante, proprio dove l’Archiano si immette nell’Arno, la cui corrente trascinò non consentendone più il ritrovamento.
Ma la sua anima venne salvata e sottratta a un diavolo che stava per portarlo all’Inferno perché Bonconte, “forato nella gola”, prima di esalare l’ultimo respiro, invocò Maria e mise le braccia a formare una croce. Bastò questo a Dio perché la sua anima venisse condotta là dove si spera e si aspetta la visione di Dio, il Purgatorio.
Tutta la Divina Commedia è misericordia, non solo nel Purgatorio o in Paradiso, ma anche nell’Inferno, quando Dante, uomo, ma illuminato da Dio, si commuove di fronte agli amanti, peccatori e dannati, Paolo e Francesca, nel V Canto, così tanto da svenire: “Caddi come corpo morto cade!”
Un altro esempio ci viene dai versi 121-123 del Canto III del Purgatorio, tra i più belli e chiari della Commedia.
Dante incontro Manfredi, che gli dice
Orribile furon li peccati miei; ma la bontà infinita ha sì gran braccia, che prende ciò che si rivolge a lei.
Dante tornerà nel Casentino, l’alta valle dell’ Arno, che fu teatro dello scontro fra Arezzo e Firenze, per essere ospite dei conti Guidi, principali signori della zona e lì scrisse gli ultimi canti dell’Inferno.
Fu nel castello di Porciano e in quello di Poppi, che nel 1310 era stato appena terminato e al cui interno è un interessante plastico della battaglia. Ma il bel castello esisteva già, visto che a Poppi si era rifugiato nel 1289 Guido Novello Guidi con i suoi armati, vista la mala parata.
Un altro bel castello legato alla memoria di Dante è quello di Romena, di cui restano ben conservati ruderi, vicino alla splendida pieve omonima.
In questi luoghi dall’aria pura è bello andare per ricordare un uomo come Dante, che seppe vedere la misericordia divina, anche nella crudezza di un’aspra battaglia. Li, vicino a luoghi di Francesco, al “crudo sasso” della Verna, fra Tevere e Arno.