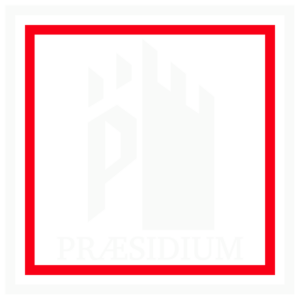Con il Mercoledì delle Ceneri nella Chiesa universale inizia la Quaresima, il periodo che precede la Pasqua ed è giorno di digiuno e astinenza dalle carni.
Il digiuno è rito e pratica importante per tutte le religioni monoteistiche: i musulmani celebrano il mese di Ramadan,
gli ebrei il kippur e i cristiani la Quaresima.
Fin dal II secolo i cristiani si preparavano alla Pasqua con due giorni di digiuno e penitenza.
Successivamente, queste pratiche furono estese all’intera settimana santa e nel 325, il Concilio di Nicea, già conosceva la preparazione alla Pasqua per 40 giorni ad imitazione di Gesù il quale trascorse 40 giorni nel deserto, così come i 40 anni nel deserto da parte del popolo d’Israele, i 40 giorni di digiuno di Mosè sul Sinai o di Elia sull’Oreb.
Con l’inizio della Quaresima cominciava anche la penitenza pubblica per coloro che si erano resi colpevoli di colpa grave (apostasia, omicidio, adulterio): vestiti con abiti penitenziali e
aspersi di cenere, giravano per le città, quasi a ricordare la “cacciata dal paradiso”.
Verso la fine dell’anno mille, la pratica della penitenza pubblica andò scemando e si mantenne l’imposizione delle ceneri a tutti i fedeli. Sin dal XII secolo, si trova usanza di ottenere la cenere dall’ulivo benedetto nella domenica delle Palme dell’anno precedente.
«Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris», ovvero: «Ricordati uomo, che polvere sei e polvere ritornerai».
Queste parole compaiono in Genesi 3,19 allorché Dio, dopo il peccato originale, cacciando Adamo dal giardino dell’Eden lo condanna alla fatica del lavoro e alla morte:
«Con il sudore della fronte mangerai il pane; finché tornerai alla
terra, perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere tornerai!».
Dopo la riforma liturgica, seguita al Concilio Vaticano II, si usa anche la locuzione: «Convertiti e credi al Vangelo» (Mc 1,15) che esprime, oltre a quello penitenziale, l’aspetto positivo della Quaresima che è tempo di conversione, preghiera assidua e ritorno a Dio.
La teologia biblica rivela un duplice significato dell’uso delle ceneri:
- Anzitutto sono segno della debole e fragile condizione dell’uomo. Abramo rivolgendosi a Dio dice: “Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere…” (Gen
18,27). Giobbe riconoscendo il limite profondo della propria esistenza, con senso di estrema prostrazione, afferma: “Mi ha gettato nel fango: son diventato polvere e cenere” (Gb 30,19).
In tanti altri passi biblici può essere riscontrata questa dimensione precaria dell’uomo simboleggiata dalla cenere (Sap 2,3; Sir 10,9; Sir 17,27). - Ma la cenere è anche il segno esterno di colui che si pente del proprio agire malvagio e decide di compiere un rinnovato cammino verso il Signore. Particolarmente noto è il testo
biblico della conversione degli abitanti di Ninive a motivo della predicazione di Giona: “I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, dal più grande al più piccolo. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere” (Gio 3,5-9). Anche Giuditta invita invita tutto il popolo a fare penitenza affinché Dio intervenga a liberarlo: “Ogni uomo o donna israelita e i fanciulli che abitavano in Gerusalemme si prostrarono davanti al tempio e cosparsero il capo di cenere e, vestiti di sacco, alzarono le mani davanti al Signore” (Gdt 4,11).
La differenza con il Rito Ambrosiano
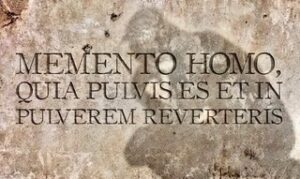 A differenza del Rito Romano, in quello Ambrosiano, che si celebra nella sola Diocesi di Milano, non c’è il rito del Mercoledì delle Ceneri.
A differenza del Rito Romano, in quello Ambrosiano, che si celebra nella sola Diocesi di Milano, non c’è il rito del Mercoledì delle Ceneri.
La tradizione ambrosiana non ha mai conosciuto questo giorno, ma ha sempre rigorosamente dato avvio al periodo quaresimale con la domenica che introduce la Quaresima, appunto, “in capite quadragesimae”.
Questo particolare rito, risale al mandato di Sant’Ambrogio, che fu vescovo di Milano dal 374 d.C. fino alla morte, e che in seguito divenne patrono della città lombarda.
Con il Mercoledì delle Ceneri, per il Rito Romano, inizia il tempo della Quaresima, ma nel Rito Ambrosiano si è ancora in pieno carnevale, con il “Sabato grasso” e solo con la domenica successiva inizia la Quaresima.
Se prendiamo il calendario e, partendo a ritroso dal Giovedì Santo, contiamo quaranta giorni, giungiamo esattamente alla prima domenica di Quaresima: i quaranta giorni della
penitenza quaresimale iniziano alla sesta domenica prima di Pasqua e giungono fino al triduo pasquale escluso, che comincia con i Vespri del Giovedì Santo.
Questo è, a grandi linee, il computo antico e originario della Quaresima, conservatosi nel Rito Ambrosiano.
In questa prospettiva, si intende la Quaresima come un periodo di quaranta giorni di penitenza ma non di stretto digiuno, dal momento che, secondo un’antichissima tradizione, di domenica (e a Milano fin dall’epoca di sant’Ambrogio, anche di sabato) non si doveva digiunare.
Nel Medioevo all’idea dei quaranta giorni di penitenza si sostituì quella dei quaranta giorni effettivi di digiuno, a imitazione di quanto fece Mosè sul Monte Sinai, Elia nel suo pellegrinaggio verso il Monte di Dio e Cristo nel deserto; parallelamente la
Quaresima fu intesa più come periodo di preparazione alla domenica di Pasqua che non al Triduo Pasquale della Passione, Morte e Risurrezione di Cristo.
Esattamente qui ci fu la necessità di un nuovo computo: se, infatti, prendendo sempre il calendario, partiamo questa volta dal Sabato Santo e contiamo a ritroso quaranta giorni, saltando però le domeniche, in cui – nel Rito Romano – non si digiunava, giungiamo esattamente al mercoledì precedente la prima domenica di Quaresima, che divenne il Mercoledì delle Ceneri.
Questo computo fu accolto dalla Chiesa Romana e si diffuse poi in tutto l’Occidente, tranne che a Milano, dove, fino ad oggi, si è conservata la più antica e precedente tradizione.
Le ceneri, «ravvivano in noi la memoria di ciò che siamo, ma anche la speranza di ciò che saremo»: così Papa Francesco ha scritto dal Policlinico Gemelli dove è ricorverato da quasi
un mese per l’omelia della celebrazione del rito delle Ceneri che si svolge nell’antichissima Basilica di S. Sabina a Roma.
Questo gesto con cui si apre la Quaresima ci aiuta
«a fare memoria della fragilità e della pochezza della nostra vita: siamo polvere, dalla polvere siamo stati creati e in polvere
ritorneremo. Fatti di cenere e di terra, tocchiamo con mano la fragilità nell’esperienza della malattia, nella povertà, nella sofferenza che a volte piomba improvvisa su di noi e sulle
nostre famiglie. (…) Da ultimo, questa condizione di fragilità ci richiama il dramma della morte, che nelle nostre società dell’apparenza proviamo a esorcizzare in molti modi e a
emarginare perfino dai nostri linguaggi, ma che si impone come una realtà con la quale dobbiamo fare i conti, segno della precarietà e fugacità della nostra vita».
Richiamo duplice, promemoria della caducità umana ma anche della speranza nella Risurrezione di Cristo:
«Se riceviamo le ceneri col capo chino per ritornare alla memoria di ciò che siamo, il tempo quaresimale non vuole lasciarci a testa bassa ma, anzi, ci esorta a sollevare il capo verso Colui che dagli abissi della morte risorge, trascinando anche noi dalla cenere del peccato e della morte alla gloria della vita eterna».
San Paolo nella prima lettera ai Corinzi (1 Cor 9,24-27) indica l’esempio dell’atleta che per conseguire la vittoria deve essere “disciplinato in tutto”: “Fratelli, non sapete che nelle corse
allo stadio tutti corrono ma solo uno conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo. Però ogni atleta è disciplinato in tutto; essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una che dura per sempre. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta “(…).
E quale è la meta per ogni cristiano? La Pasqua evento grandioso della nostra fede: “Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede” ( S.Paolo, 1 Cor.15).
Pasqua, luce del nuovo splendore.
È Pasqua; Pasqua del Signore…
O tu, che sei veramente tutto in tutti!
Di ogni creatura gioia, onore, cibo, delizia; per mezzo tuo sono state fugate le tenebre della morte, la vita è data a tutti, le porte del cielo si sono spalancate.
Dio si è fatto uomo e l’uomo è elevato a somiglianza di Dio. O Pasqua divina!…
O Pasqua, luce del nuovo splendore...
– Ps. Ippolito, Omelia VI sulla Pasqua, Inno –
E’ ora di correre!
Alessandro prof. dott. Tamborini
*Plenipotenziario per le politiche di tutela e promozione del patrimonio storico-artistico-Teologo, cattedratico e studioso di Scienze Religiose, Storia e Simbolismo dell’Arte Antica e Medievale.