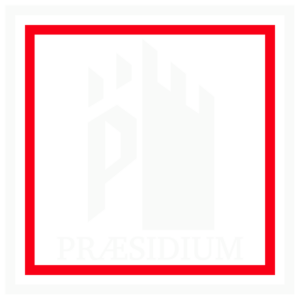Forlani Attilio nasce a Castellammare Adriatico in Contrada Vittorio Emanuele il 4 maggio 1896 figlio di Giuseppe Forlani (calzolaio) e Antonia di Luca (casalinga).
Negli anni inizierà il lavoro di fuochista presso le ferrovie e si iscrive al Fascio di Castellammare Adriatico (Pescara). È uno dei protagonisti fascisti attivi nello stroncare lo “sciopero legalitario” di fine luglio/inizi agosto 1922.
Perse infatti la vita la notte del 1 agosto 1922 per mano comunista presso la linea ferroviaria di Ancona tra Varano e Osimo. Il Forlani aveva il compito di ricondurre il treno, direttissimo proveniente da Bari, presso il deposito di Castellammare Adriatico quando in località Aspio (una frazione del paese Camerano della provincia di Ancona) causa dei bulloni delle rotaie allentati dai sovversivi il direttissimo deraglia e il fuochista Forlani muore tranciato in due.
Rimangono inoltre feriti il macchinista, un ingegnere delle Ferrovie e un viaggiatore[1].
Come si svolse lo “sciopero legalitario”?
“Se ne fecero iniziatori elementi estremisti del Sindacato ferrovieri e lo imposero con la violenza, minacciando con la rivoltella il recalcitrante rappresentante della C.G.L. nel “comitato segreto”[2].
L’ultimo tentativo messo in atto per cercare di bloccare l’avanzata fascista. Uno sciopero che avrebbe dovuto essere segreto fino all’ultimo ma che, erroneamente, già il 30 luglio apparve suo giornale di Genova Il Lavoro [3] il proclama e la notizia dell’imminente sciopero.
Durante lo sciopero i sovversivi presero di mira soprattutto il servizio ferroviario, ma nonostante tutte le minacce ricevute il Forlani non si tirò indietro e decise di partecipare ugualmente per stroncare lo sciopero e per il forte amore che nutriva per l’Italia.
Infatti i fascisti si organizzarono immediatamente: la direzione del PNF diede immediate disposizioni per la mobilitazione delle squadre; intanto Michele Bianchi a nome del partito pose un ultimatum al Governo: 48 ore di tempo per stroncare lo sciopero.
In caso contrario le camicie nere interverranno in prima persona per far cessare uno sciopero che avrebbe danneggiato il paese e dimostrato la debolezza dello Stato.
La Caporetto socialista
L’Alleanza del Lavoro decide la fine dello sciopero per il 3 agosto a mezzogiorno “per non dare l’impressione di cedere all’ultimatum fascista, che spira il 2 agosto a mezzanotte” [4].
I fascisti non persero tempo e ruppero gli scioperi facendo funzionare i servizi pubblici e lavorare parecchi stabilimenti industriali.
Fu la ‘Caporetto’ socialista. Tre giorni dopo l’organo socialista riformista La Giustizia [5] ammise:
“Bisogna avere il coraggio di confessarlo: lo sciopero generale proclamato ed ordinato dall’Alleanza del lavoro è stata la nostra Caporetto. Usciamo da questa prova clamorosamente battuti (…) In tutti i più importanti centri la raffica fascista si sferra con uguale violenza distruggitrice (…) Bisogna avere il coraggio di riconoscerlo: i fascisti sono oggi i padroni del campo. Se volessero potrebbero continuare a menar colpi formidabili, sicurissimi di nuovi successi”.
Il racconto dei funerali di Attilio
La figura di Attilio Forlani e il suo sacrifico trovano largo spazio su Il Popolo d’Italia con un articolo, firmato da Gaetano Polverelli, che descrive minuziosamente i funerali.
“Castellammare, città di sole, di quiete e di sogno, si è raccolta piamente attorno alla salma del ferroviere Attilio Forlani, l’eroe giovanetto, martire del dovere, che una locomotiva tagliò orribilmente in due tronconi per un barbaro attentato degli scioperanti rossi sulla linea di Ancona.
Da Francavilla, alta sul mare, a Pescara dannunziana, da Chiesti, da Teramo, da Sulmona, da Aquila e su dalla lontana, aspra Tagliacozzo, erano giunti le rappresentanze d’Abruzzo. Intorno alla bara coperta dal tricolore erano corone e corone, tante da formare un giardino.
Quattro ferrovieri fascisti, in camicia nera e berretto da fatica, sostenevano a spalle il feretro, fiancheggiato da quattro fascisti in elmetto di guerra. Il corteo era interminabile: popolani, contadini, donne vestite a lutto, le quali recavano un senso di tragicità eschilea.
Ma alla pietà del popolo si univa la fierezza virile e maschile. Squadre di fascisti, che sfilavano mute e serrate, come legioni, al comando di un giovane ufficiale, dal viso brunito, il Giannantonio. Nel primo rango marciavano i deputati fascisti Acerbo e Sardi. La Direzione del Partito Nazionale Fascista era rappresentata dal decoratissimo capitano Starace.
Il padre del povero Attilio Forlani, a capo bassi, col cuore straziato, seguiva senza piangere, con la fierezza di un antico romano. Quanta virtù in questo popolano! Nella mattinata avevamo visto che la povera madre muta e ferma come una statua, simile ad una madre spartana. Questa fierezza dell’antico sangue abruzzese era nobilmente rivelata dalle squadre fasciste, da quei giovani rudi e duri che recavano sul petto i segni del valore di guerra.
L’Abruzzo, ci diceva l’on. Sardi, non ha avuto imboscati e non ha avuto disertori durante la guerra! I fanti e le bandiere Abruzzesi hanno conquistato una ventina di medaglie d’oro. Un reggimento abruzzese partì con quattromila uomini e fu ricostituito ancora, ma di abruzzesi non ce n’erano più… Erano caduti tutti nelle difese e negli assalti.
“A questa razza apparteneva Attilio Forlani, il quale volle servire la Nazione in pace, come l’aveva servita in guerra.
Egli ben sapeva di affrontare il pericolo recandosi in servizio verso quel covo di teppa turbolenta e sanguinaria, che era sino a ieri Ancona. Ma era partito ugualmente e decisamente, per servire la Nazione, per rompere lo sciopero, per opporsi al cinico delitto antinazionale.
L’on. Acerbo, parlando al popolo, ha messo in rilievo il significato politico di questo sacrificio: “E’ la prima volta che un ferroviere muore per spezzare la follia rossa e ricostituire l’ordine nazionale contro il disordine socialista. La responsabilità degli ultimi avvenimenti – ha soggiunto l’on. Acerbo – anche per quanto riguarda le rappresaglie fasciste, ricade sui cinici speculatori antinazionali, ricade sui capi del socialismo”.
L’on. Sardi, prendendo la parola dopo il deputato Acerbo, ha avuto un bellissimo impeto lirico, paragonando il sacrificio del ferroviere Forlani durante lo sciopero, al sacrificio dei fanti sul Piave; e, poiché parlava dinnanzi alla stazione l’on. Sardi ha detto: “Quella era per Forlani la vera casa del lavoro e non la casa del complotto e del tradimento!”.
Hanno salutato la salma anche il fascista Trolio e il capitano Starace, il quale ha parlato vibratamente, alla maniera militare. In chiesa il sacerdote ha benedetta la salma e ha invocato la luce perpetua per l’eroe: certamente il suo spirito non morrà e il nome di Forlani rimarrà a memoria di un eroe, fulgido esempio per le nuove generazioni di operai fascisti.
Quando la salma era in mezzo alla chiesa, vigilata militarmente da quattro fascisti e coperta dalla bandiera nazionale e l’organo suonava una lenta liturgia, noi abbiamo pensato che realmente assistevamo alla celebrazione di un eroe.
“Battisti, Sauro, Rismondo furono i nostri santi della guerra; Forlani è uno dei nostri santi in pace. Una squadra ha scortato militarmente la salsa fino al camposanto, su un’altura di fronte al mare; ma il cuore di tutta Italia ti segue, o eroe giovinetto, oscuro fino a ieri, da ieri grande e sacro!”.
Nel primo anniversario della sua morte fu inaugurato un monumento alla sua memoria proprio nel luogo della sua morte[6].
Si sottolinea che nel paese di Cepagatti (Pescara) è ancora presente una via cittadina a lui intitolata.
Note
[1] G.A. Chiurco, Storia della Rivoluzione Fascista, vol. IV 1922
[2] A. Tamaro, Venti anni di storia 1922-1943, vol. I
[3] S. Antonini, Storia della Liguria durante il fascismo, De Ferrari, Genova, 2006
[4] G. Pisanò, Storia del fascismo. Dalle origini alla conquista del potere (1914-1922)
[5] 12 agosto 1922
[6] De Simone, Pagine eroiche della Rivoluzione Fascista