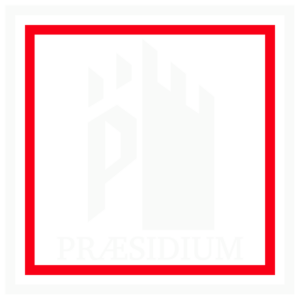Una piccola premessa: L’articolo è stato scritto per “Il Secolo d’Italia” ma è a sua volta tratto dal primo volume di due, dal titolo “Il pensiero di destra propone”, editi dalla Ciarrapico edizioni nel 1980 con l’obiettivo di racchiudere una vasta selezione degli articoli presenti all’interno della rubrica culturale dell’organo di stammpa del M.S.I. chiamata a sua volta “Secolo cultura”. Il libro “Gli eroi” di Carlyle è attualmente ristampato dai tipi di Oaks edizioni.
Ribattitura a cura del progetto d’archiviazione e salvaguardia del Centro Studi e ricerca Cittadella
La rinascenza della cultura, fenomeno che va manifestandosi prepotentemente in tutto il mondo e che noi non ci stancheremo mai di sottolineare, passa anche attraverso la ripresa di determinate tematiche contro le quali l’usura del tempo nulla ha potuto, sicché il loro riapparire è la testimonianza più viva di un intrinseco valore perenne.
La crisi delle ideologie egualitarie e mercantilistiche ha come contraltare- e non potrebbe essere diversamente- la riscoperta di categorie culturali che per troppo tempo sono state relegate nel retrobottega di un trovarobe qualsiasi nella illusoria convinzione di tenercele per sempre.
Il mito dell’eroe è uno di quei paretiani residui della storia che non avrebbero dovuto più avere cittadinanza nelle riflessioni degli intellettuali; e se noi oggi ne parliamo non è soltanto perché ne riteniamo legittima la presenza, ma anche per fare giustizia dei troppi luoghi comuni affastellatisi sull’argomento. Provocazione intellettuale?
Certamente.
Ogni verità che sappia elevarsi sulla menzogna con il solo ausilio della propria forza è provocatoria, cosi come lo è stata una grande presa di posizione, scientificamente fondata, sull’eroe e l’eroismo all’apogeo dello stupido XIX secolo: quella dello scrittore inglese Thomas Carlyle (1795-1881).
In un’opera che giustamente raccolse vasti consensi, ingiustamente pressoché dimenticata, Gli eroi, il culto degli eroi, l’eroico nella storia (1841), Carlyle ha disegnato con molta efficacia e chiarezza la tipologia dell’eroe e la concezione dell’eroismo nelle esperienze storiche dei popoli. La costante apparizione nel tempo di personalità eccezionali ha segnato per buona parte la differenziata vita delle genti.
«Nessun grande uomo vive invano. La storia del mondo non è altro che la biografia dei grandi uomini»
Scrive Carlyle, aggiungendo che il culto degli eroi e dell’eroico caratterizza le vicende umane più di quanto non si sia portati a credere, dal momento che la storia universale, la storia di tutto ciò che l’uomo ha compiuto nel mondo, non è altro che la storia drammatica, disperata, sublime e gloriosa al tempo stesso- degli uomini che hanno avuto la forza di trasformare il mondo, in un cimento ardito contro ogni ostacolo, secondo la propria volontà.
Questi grandi uomini sono stati i modellatori, i patroni, i creatori di tutto quello che le masse hanno potuto fare e raggiungere; tutto ciò che vediamo nel mondo è il risultato pratico dell’incarnazione di un’idea informatrice che ha supportato l’azione dell’eroe (in senso lato).
Carlyle per definire il culto degli eroi elabora uno schema quanto mai originale, ma tuttavia non fantasioso chimerico. Individua sei categorie di eroi: l’eroe come divinità; l’eroe come profeta; l’eroe come poeta; l’eroe come sacerdote; l’eroe come letterato; l’eroe come re.
Nel primo caso, lo scrittore inglese prende in considerazione la concezione nordica che in una particolare forma di immanenza vuole Dio tra gli uomini. Un valore che è stato difficile da estirpare dall’animo scandinavo, per esempio, e che è valso come forma di illuminazione per i popoli dei fiordi.
L’eroe è Dio (Odino) da sempre o può diventarlo: morire in battaglia è un’occasione di deificazione –così come lo è per gli Atzechi o per gli Incas.
Nell’Edda di Snorri è detto che gli scandinavi consideravano vergognoso non morire in battaglia e se la morte naturale si avvicinava, i più valorosi si tagliuzzavano la carne di ferite perché Odino potesse riceverli come guerrieri uccisi.
«I vecchi re -scrive Carlyle- all’avvicinarsi della morte, si facevano mettere su una nave, e la nave veniva lanciata, con le vele issate e un lento fuoco che la bruciava, affinché una volta in alto mare, potesse incendiarsi e fiammeggiare in alto, seppellendo così degnamente il vecchio eroe, nello stesso tempo su nel cielo e giù nell’oceano».
La seconda fase del culto degli eroi è caratterizzata dal fatto che la personalità eccezionale non è più Dio, ma un ispirato da Dio, un profeta.
Carlyle considera il mondo dell’Islam e la prepotente figura di Maometto per il semplice fatto che grazie ad esso un povero popolo pastore, nomade, uscì dalle tenebre e vide la luce.
Grazie ad un profeta mandato dall’alto un mondo si fa conoscere al resto dell’umanità, brilla di proprio splendore, la fede è grande e dà vita.
«La storia di una nazione diviene feconda, elevatrice di anime, grande, dal momento che ha una fede».
L’eroe come poeta vede l’attenzione di Carlyle concentrata sulle altissime figure di Dante e Shakespeare. Il poeta -afferma lo scrittore- è una figura eroica che appartiene a tutti i tempi; basta saperla discernere e valersi delle sue intuizioni.
È eroe perché ha il potere di essere inteso universalmente da tutti gli uomini dal momento che ha penetrato il sacro mistero dell’universo, quello che Goethe chiama il segreto aperto scrutato quasi da nessuno.
È il Vate che sa parlare ad una Nazione: non è stato forse questo il ruolo specifico di Dante nella tribolata Italia delle fazioni e delle mortali divisioni?
Più forte dei cannoni la sua voce ha possibilità di incidere, perché scende nel cuore degli uomini esaltandoli o fustigandoli, comunque indicando loro una missione da compiere in aderenza ad un destino non scritto.
Anche il sacerdote è una forma d’eroe per Carlyle. Egli è una specie di profeta e presiede all’adorazione del popolo unendolo al Santo invisibile. Sacerdote come Pontifex, facitore di ponti fra l’umano ed il superumano, fra l’uomo e Dio.
Fra il conosciuto e l’inconoscibile, fra il visibile e l’invisibile
«Egli fa appello alla giustizia invisibile del cielo contro la forza visibile della terra e sa che essa, l’invisibile, è forte ed e la sola che sia forte, Egli è un credente nella divina verità delle cose, un veggente, che guarda attraverso le apparenze delle cose, un adoratore, in un modo o nell’altro, della divina verità delle cose: in una parola, un sacerdote».
E a costo di stupire, Carlyle rivela pure l’esistenza della figura dell’eroe come letterato.
Un prodotto dei tempi moderni, certamente, ed è una delle forme più inattese di eroismo, ma è fortemente tale perché ciò che insegna incide sul comportamento del mondo intero. Letterati come Johnson, Rousseau, Burns – che Carlyle considera molto da vicino – hanno avuto la forza di muovere grandi masse secondo i propri voleri.
«I libri non compiono anche miracoli, come, secondo la favola, li facevano le rune? Essi persuadono gli uomini. Fino al più miserabile romanzo della biblioteca circolante, che sciocche ragazze sporcano e rileggono nei villaggi lontani, deve contribuire a regolare effettivamente e praticamente i matrimoni e le case di quelle sciocche figliuole».
E finalmente l’ultima forma di eroismo classificata da Carlyle: l’eroe come re. Egli è in pratica il riassunto di tutte le varie forme di eroismo fin qui considerate: le incarna tutte per dire agli uomini ciò che devono o non devono fare. Rex, regolatore delle volontà umane, ma anche dei desideri, dei bisogni degli uomini.
Ogni tempo ha il suo eroe, o più eroi, o nessun eroe: a tale forma tuttavia sempre ci si avvicina o si cerca di avvicinarsi. I tempi presenti ne conoscono una, per dirla col Carlyle: l’eroe-letterato che poi è l’eroe-pamphlettista, l’eroe-giornalista.
Una forma desacralizzata, senza dubbio, ma in grado di piegare le masse ai propri voleri: oggi non si adora più un Dio o un profeta, non si segue più un sacerdote o un capo carismatico, ma si mitizzano coloro i quali fanno leva sullo spirito dei tempi gonfiando a dismisura, talvolta, i bisogni elementari dell’umanità, deificandoli, assolutizzandoli, rendendoli feticci a cui doverosamente va l’ossequio della venerazione.
Il dato saliente delle intuizioni carlyliane è quello di aver individuato il ruolo classico dell’eroe, che può manifestarsi sotto le spoglie più varie, nella forza rivoluzionaria-trascinatrice, incarnando nel contempo una funzione pedagogica ed analogica, nel senso cioè di avere la capacità di suscitare ed alimentare la disposizione del singolo ad agire e pensare, a vivere, lottare ed eventualmente sacrificarsi in funzione di qualcosa che va al di là della semplice individualità.
L’analisi di Carlyle lascia molti punti interrogativi senza risposta, ma anche una certezza: l’eroe c’è, in ogni tempo, basta saperlo cercare.