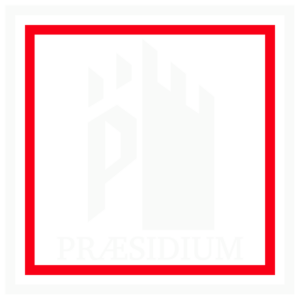Praesidivm: Quale bilancio si può fare dell’esperienza militare italiana in Afghanistan?
M. B.: Il bilancio, per quanto riguarda le Forze Armate, è decisamente positivo. Sotto un profilo tecnico, vent’anni di impiego operativo ha consentito alle Forze Armate, soprattutto all’Esercito, di impadronirsi delle più recenti innovazioni in campo dottrinale e procedurale. Abbiamo migliorato alcune delle nostre dotazioni, relativamente alle armi e ad alcuni mezzi, e certamente le nostre Forze Armate hanno dimostrato di essere in grado di alimentare sforzi impegnativi, a grande distanza da casa, anche senza contare su grandi risorse. Da un punto di vista più “sociale”, si deve all’impego dei nostri militari se una generazione di venti-trentenni afghani sono cresciuti in un ambiente un po’ più sicuro di quello nel quale erano cresciuti i loro genitori. Soprattutto, i nostri militari si sono affermati per la loro professionalità ed anche per il loro coraggio di fronte ad occhi attenti, come quelli della popolazione locale e degli alleati, e questo è molto importante. Decenni di propaganda disfattista nel nostro paese avevano infatti imposto l’idea di una sostanziale incompatibilità tra italianità e militarità. Un’idea assurda, visto quello che i nostri padri e i nostri nonni hanno fatto, ma che non poteva non lasciare il segno in un contesto generale nel quale la storia che non si riesce a cancellare viene comunque alterata. E questo credo sia il risultato più importante per noi, come Italiani. Voglio chiarire con un esempio: solitamente in Italia molti giovani in cerca di impiego scelgono le Forze di Polizia, per il prestigio di cui godono ma anche per il richiamo che l’uniforme esercita sempre nei migliori. Questo, invece, non è accaduto nel periodo più “cinetico”, per usare un eufemismo statunitense affermatosi in Afghanistan, quando in quel “teatro” avevamo molti scontri che ci causavano caduti e feriti con grande frequenza ed erano numerosissime le richieste di arruolamento nell’Esercito. Infatti, l’impegno rischioso, in un contesto insalubre e difficile nel quale veniva messa alla prova la capacità di sopportazione di disagi e fatiche non indifferenti, la Forza Armata di terra si trovava a dover rifiutare l’arruolamento a molti validissimi giovani che lo chiedevano, perché “troppi” per i nostri organici. Il confronto con quello che accade ora, in un periodo nel quale i soldati vengono impiegati in operazioni come Strade Sicure, nelle quali li si utilizza come piantoni e a scopo di deterrenza nelle nostre strade, è impietoso. Ora molti dei migliori soldati cercano di transitare nelle Forze di Polizia e un grande numero di quelli che continuano a scegliere l’Esercito lo fanno col retropensiero di transitare, prima o poi, nell’Arma, in Polizia, nella Finanza o nel Corpo delle Guardie Carcerarie. In ogni caso, le specialità una volta più “gettonate”, come i paracadutisti, registrano un passivo di vocazioni palese.
Praesidivm: Come giudica l’epilogo della ventennale guerra ai Talebani?
M. B. Il fallimento dell’operazione è sotto gli occhi di tutti: quello che per vent’anni era stato investito del ruolo di “Nemico perfetto”, perché oscurantista, maschilista e certamente omofobo, arriva senza combattere nella Capitale del paese dalla quale si era giurato di volerlo tenere alla larga. Ma poche cose resistono al tempo che passa e certamente anche le strategie statunitensi cambiano. E non dobbiamo dimenticare di essere intervenuti in Afghanistan, come in altre parti del mondo d’altronde, per scelte americane, tutt’al più condivise con quella alleanza tra anglosassoni, la “Five Eyes”, che in questi giorni si sta dando una struttura ufficiale con una fornitura di sottomarini nucleari all’Australia, che potrebbero trasformare il quasi deserto nuovissimo continente un una semi-superpotenza. Insomma, in Afghanistan certamente gli Usa hanno visto venir meno la possibilità di imporre una democrazia nei cui confronti esercitare la propria influenza, ed hanno così aperto un’altra strada: quella di richiamare in vita quei mujaheddin che avevano appoggiato in funzione antisovietica nel passato. E il fatto che gran parte di questi siano oggi i Talebani, poco conta. Questa è stata certamente la scommessa di Trump, che aveva voluto i colloqui di Doha che hanno messo fine alla guerra e consentito lo sganciamento occidentale e statunitense. Uno sganciamento che le nostre forze politiche hanno per due decenni auspicato, affettando un palese disinteresse per quello che i nostri militari facevano in quel paese, salvo poi lamentare la vittoria dei barbuti studenti coranici, a giochi ormai fatti. In ogni caso, non c’è dubbio che l’operazione non poteva durare in eterno, anche se lo sganciamento è stato gestito malissimo, senza quella progressività che certamente era nei patti ma che non è stata ottenuta sul campo. Le ragioni sono certamente molte, prima di tutto la volontà del Presidente afghano Ghani di evitare una resistenza inutile, visto che l’accordo tra talebani e statunitensi che toglieva ogni prospettiva di vittoria. Poi c’è stato un effetto psicologico dovuto alla repentina scomparsa degli statunitensi ai quali gli afghani riconoscevano il ruolo di “Governo di fatto” del paese, indispensabile puntello al Government of the Islamic Republic of Afghanistan, che su esso contava per la propria sopravvivenza. Una specie di 8 settembre in salsa afghana, insomma, nel quale il ruolo del Re e di Badoglio che abbandonano la capitale per scappare a Brindisi viene preso dagli americani e dai loro alleati. Sarebbe ipocrita biasimare, quindi, il comportamento di un esercito e di un popolo ai quali non possiamo imporre di sacrificarsi ancora un po’, di “morire sul posto” per tacitare il nostro amor proprio tradito. O in nome dei nostri principi di ex alleati che ci hanno ripensato. Che gli afghani non siano un popolo di deboli, d’altronde, è provato da secoli di storia e certamente se hanno deciso di porre fine a più di quarant’anni di guerra non sta a noi criticarlo o meno.
Praesidium: Spesso le missioni militari delle Forze Armate sono descritte dai politici e dagli organi di informazione, come funzionali ad esportare nelle aree di intervento il modello democratico occidentale, considerato la migliore forma di organizzazione del consorzio umano associato. In sostanza, secondo questa visione, i nostri militari dovrebbero creare le condizioni affinché si impongano quei modelli esistenziali che caratterizzano l’Occidente democratico, modelli spesso e volentieri contrari all’etica che, da sempre, caratterizza lo stile di vita militare. Come vive un soldato questa situazione, davvero si può sacrificare la propria vita in nome dello sbrago occidentale?
M.B.: I soldati fanno quello che viene loro chiesto dal proprio paese, nell’intesa che così facendo si difendano i suoi interessi vitali. In ogni caso, il giudizio sulla democrazia non deve appiattirsi su quello della sua spesso riprovevole applicazione pratica. Se c’è qualcosa di sbagliato da un punto di vista concettuale non è infatti nel principio per il quale i popoli hanno il diritto di scegliere i propri governanti, ma anzi il contrario: quello per il quale in nome di situazioni “eccezionali” come quelle che da anni interessano il nostro paese, si impedisce la verifica del consenso popolare per sostituirlo con scelte di vertice. Ciò premesso, in effetti in Afghanistan c’è stato un velleitario tentativo di imporre un sistema di stampo occidentale, nel quale i cittadini si dividano in partiti sulla base dei propri convincimenti ideologici o politici. Ma questa velleità è responsabilità dei governi, non degli eserciti. Così facendo, non si è voluto riconoscere che c’è una parte importante del mondo, non limitata all’Afghanistan, nella quale la gente si divide sulla base della propria appartenenza etnica, magari della propria appartenenza religiosa, che spesso alla prima si sovrappone, non certamente per il programma col quale un governatore vorrebbe costruire strade, mentre il suo concorrente preferirebbe promuovere il sistema scolastico. O distruggerlo come è stato fatto in Italia da molti decenni. Insomma, in quel mondo si vota e ci si divide per disciplina e per appartenenza, non per convincimento su un aspetto o un altro del programma di governo. O per condizionamento ideologico. E questa è una realtà che in larga misura è comune anche al Medio Oriente, a due passi da casa nostra, e nel quale chi pretendesse di imporre la logica democratica dei nostri partiti dimostrerebbe di non avere capito cosa è quella terra. Una terra che un tempo preferivamo definire “Vicino Oriente”, per i rapporti strettissimi che da sempre ha avuto con la nostra Europa. Ammesso che gli interventi occidentali che vi si sono esercitati da molti decenni siano stati mossi da buona fede, è infatti certamente ad essi che si devono imputare molte magagne e molti problemi, pagati col sangue delle popolazioni locali. Come nel caso della Siria, dove la pretesa di rimuovere il Presidente Assad – che per convenzione pelosa i nostri media e politici definiscono “dittatore” – ha contribuito a giustificare una guerra di aggressione da parte di ISIS e Hayat Tahrir al Sham che ha causato centinaia di migliaia di morti e distruzioni spaventose. E questo, in un paese islamico favorevole e amichevole come pochissimi altri nei confronti della cospicua componente cristiana che viveva in pace nello stesso, fino al punto che al “dittatore” il nostro Presidente della Repubblica pro tempore aveva concesso l’importantissima onorificenza di Cavaliere di Gran Croce decorato di Gran Cordone dell’Ordine «Al merito della Repubblica Italiana»; salvo ritirargliela qualche anno dopo per le pressioni di chi aveva deciso di dare una svolta non incruenta alla storia del Mediterraneo con l’esplosione delle Primavere Arabe.
Insomma, in Afghanistan non è l’idea di democrazia che è in discussione, ma il razzismo di fondo di un Occidente democratico e, per dirla con Bardéche, appassionato proclamatore di grandi principi che si guarda bene dall’applicare, e che predica un’uguaglianza che tale dimostra di non essere ogniqualvolta la vuole imporre con la forza delle armi. O delle sanzioni.
*Il Generale di Corpo d’Armata (Aus.), Marco Bertolini, è nato a Parma il 21 giugno 1953. Figlio di Vittorio, reduce della battaglia di El Alamein, dal 1972 al 1976 Marco Bertolini ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e la Scuola di Applicazione d’Arma di Torino. Nel 1976, con il grado di Tenente, ha prestato servizio presso il IX Battaglione d’Assalto Paracadutisti “Col Moschin” del quale, per ben due volte (dal 1991 al 1993 e dal 1997 al 1998), è stato comandante. Già comandante, dal 1999 al 2001, del Centro Addestramento Paracadutismo, dal 2002 al 2004 è stato posto al comando della Brigata Paracadutisti Folgore, per poi assumere il comando interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS) e, successivamente, quello del Comando Operativo di vertice Interforze (COI). Dal luglio del 2016 Marco Bertolini ha cessato il suo servizio attivo nelle Forze Armate. Attualmente è Presidente dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia.