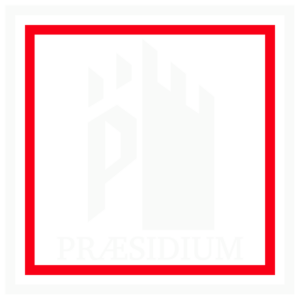In un tempo sciagurato come il nostro, in cui la figura del “capo” – di partito, di governo, o anche di un semplice ufficio o reparto – è intrisa di compromesso ed esercizio fine a sé stesso del potere, stupisce quale carico di valori la tradizione indoeuropea abbia saputo ascrivere alla figura del “Primo”.
A questo proposito, è davvero suggestivo l’antico detto delle popolazioni nordeuropee, per cui “Chi è capo ci sia ponte”, che deve interpretarsi come “chi è davvero capo, chi ne ha il crisma, si schieri in prima fila e faccia di tutto per la propria gente, a costo della vita, a costo di farci passare armati su di lui, in furia, contro il nemico”.
E se un capo non è tale, lo spirito e la condotta di vita – in pace e in guerra – ne sono l’immediata, impietosa cartina tornasole. Il disprezzo, l’allontanamento sono la moneta amara che il capo indegno deve subire, prima ancora che la perdita del “potere”.
Toccando l’argomento “potere”, si avverte l’attrito maggiore fra la nozione antica della qualità di capo e quella – deprezzata, caricaturale – che caratterizza a qualsiasi livello i ruoli dirigenti attuali, conseguenza inevitabile del paradosso, tutto illuminista e giacobino, che vuole il capo eletto per la volontà della moltitudine indifferenziata anziché investito naturalmente, per propria indole e vocazione interiore, di una potestà superiore sulle persone e sulle cose.
Il potere, oggi, è sempre più inteso – superficialmente e maldestramente – come semplice sinecura, ossia come vuoto contenitore di benefit e vantaggi, soprattutto di ordine materiale. Quando il capo comanda, sia il preside di una scuola, il Presidente del Consiglio, il direttore di un oratorio, il palazzinaro ricercato, si avverte che è il denaro l’unico barometro della sua posizione.
Stupisce, quindi, pensare a come, nell’antichità risalente ma anche in quella più prossima a noi, molto spesso i locali, gli indumenti e le cerimonie più spartane ed essenziali erano quelle che riguardavano il capo. Il suo carisma, la sua dignità, infatti, bastavano a caratterizzarlo unitamente a pochi, chiari simboli: la toga di un determinato colore, il globo che rappresenta il mondo, lo scettro che è l’asse terrestre, prerogative cerimoniali ben definite.
Correva, infatti, una sostanziale e marcata differenza fra il tiranno, ossia colui che esercitava il potere esteriormente, in maniera fine a sé stessa, e il capo, la guida legittimata ad esercitare il proprio ruolo. E la condizione di questa guida, peraltro, non era quella del boss in febbrile e perenne attività, con cellulari squillanti e automobili ruggenti, ma era più simile a quella di una statua di pietra: immobile ma densa di gravità, rigida ma plasmabile dalla luce cangiante delle situazioni, centro stabile di un mondo gerarchicamente ordinato, di potestà in potestà.
Il princeps – inteso in senso lato – è quanto di più diverso possa immaginarsi dal “capo” dell’epoca attuale: è un motore inamovibile, emblema di stabilità (“salde sono le montagne e saldo è anche questo Re degli Uomini”, recitano i testi indiani), coraggio e sacrificio personificato, anzi sovente vittima sacrificale perché l’ordine cosmico non fosse turbato. Troviamo qualcosa di più lontano dall’immagine imbolsita e vile del “Direttore” odierno, affondato nella propria poltrona, circondato da oggetti di “design” e da lacché compiacenti? Ne proviamo quasi vergogna.
Riflettiamo molto su queste differenze, se vogliamo – nel nostro piccolo o grande ruolo nel mondo attuale – essere capi, ossia – anzitutto – padroni carismatici di noi stessi.